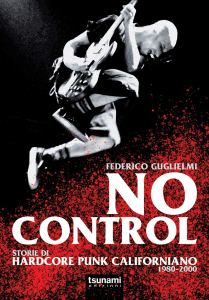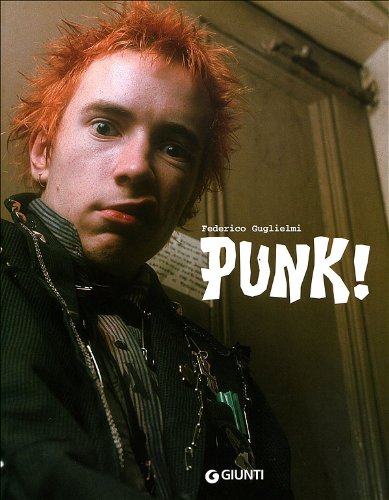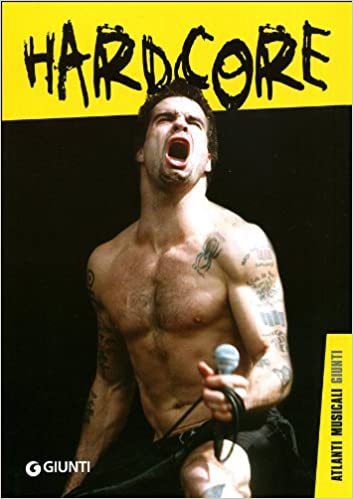Musica ribelle
“A Milano vivevo in questa realtà di Movimento della quale faceva parte anche Demetrio Stratos degli Area, che avevo conosciuto alla Numero Uno; lui era una specie di ponte tra la generazione dei più anziani e quella di noi giovani, e poi era un altro semi-apolide come me… un greco nato ad Alessandria e cresciuto con il mito del rock e del blues che viveva a Sassuolo… mi aveva adottato come un fratellino. Fu Demetrio a portarmi a conoscere Gianni Sassi, il deus ex machina della Cramps. A differenza di mio padre, che era un vecchio liberale conservatore con il quale per forza di cose litigavo da matti, Gianni era una figura incredibilmente stimolante: ti raccontava di Duchamps o di Giotto, ti dava un libro da leggere e in qualche modo ti influenzava, tanto che rientrato a casa ti trovavi automaticamente a scrivere. In studio mi ha sempre dato carta bianca, voleva solo che non gli rompessi le palle per le copertine. Da buon pubblicitario mi ha creato l’immagine, che però non corrispondeva proprio alla realtà: davo l’impressione di un figlio del popolo, di un meccanico dell’hinterland milanese, e parecchi storcevano la bocca nello scoprire che non era così. D’altronde io non riuscivo proprio a essere rigoroso e triste come i “colleghi” cantautori, e in più ero borghese, americano e rock; si sa, la cultura di Sinistra non è mai stata molto rock e ha sempre sospettato della musica in quanto musica… ai festival dell’Unità ancora mi succede, dopo trent’anni di militanza e di sostegno della causa, che qualche organizzatore mi guardi storto”.
Svincolato senza problemi dalla Numero Uno, Finardi si lega dunque alla Cramps, etichetta davvero fuori dai canoni del mercato convenzionale che ha come alfieri gli Area e che appoggia proposte rock, d’avanguardia, filo-jazz e cantautorali quanto più possibile creative. Nell’estate del 1975 arriva così Non gettate alcun oggetto dai finestrini, “summa” delle idee elaborate assieme ad Alberto Camerini e messe in bella copia con l’aiuto di musicisti di valore come lo stesso chitarrista, la sezione ritmica Hugh Bullen/Walter Calloni e il violinista Lucio Fabbri (e c’è pure Battiato, accreditato con lo pseudonimo Franc Jonia, al synth VCS 3). “Ai tempi avrei parlato di collettivo, ma in verità il suono era mio e di Alberto. L’atteggiamento di base era quello della “jam controllata”, ancor oggi distintivo della mia musica. Non mi interessa una creazione intellettuale complessa, di tipo romantico, bensì un veicolo tramite il quale portare emozioni collegate in diretta; cerco la verità emotiva dei musicisti, ci tengo a farli esprimere al loro meglio tirandone fuori la cifra, e miro infatti a trovare persone che suonino in un certo modo e a gestirne le dinamiche”. Coprodotto da Finardi, Camerini e Massimo Villa, il disco allinea sette pezzi mediamente lunghi in bilico tra rock e jazz/fusion, con qualche accento pop, qualche dilatazione di gusto prog e testi che pur mettendo in primo piano l’impegno non mancano di soluzioni atipiche, specie per gli standard seriosi del “giro”: emblematica la Se solo avessi d’apertura, fin dalla prima strofa “Se solo avessi un Kawasaki / allora sì che mi farei tutte le donne che vorrei”. “Naturalmente volevo essere ironico, ma pochi lo hanno capito. Allora quasi tutti facevano gli ermetici, mentre io esprimevo i concetti con chiarezza, pane al pane e vino al vino. Ho sempre odiato i dogmatismi, le liturgie, le recite… in questo sono assolutamente americano, penso al contenuto, al succo. Qui in Italia, ma non solo qui, regnano luoghi comuni devastanti, che hanno soffocato il senso critico: manca il coraggio della verità intellettuale e di quella emotiva, e ciò alimenta la rabbia elettrica della mia musica“. Non c’è tantissimo rock’n’roll, in Non gettate alcun oggetto dai finestrini: a ben vedere, gli unici pezzi incalzanti – i due di maggiore durata, paradossalmente – sono la summenzionata Se solo avessi, sorta di trait d’union tra Area e Premiata Forneria Marconi, e la cover marziale/rurale di Saluteremo il signor padrone. Qualche lampo accende Quando stai per cominciare (una ballata contro il servizio di leva) e La storia della mente, cofirmata con Claudio Rocchi e tendente alla psichedelia, mentre più soffici e avvolgenti sono Taking It Easy (unico episodio in inglese: un vezzo, se così lo si vuol definire, al quale il Nostro di rado rinuncerà), Caramba(dedicata a un ipotetico, giovane tutore dell’ordine, visto come uomo e vittima invece che come nemico) e Afghanistan, piccolo inno scuoti-coscienze composto a quattro mani con il solito Camerini. A dispetto delle inevitabili ingenuità, un esordio più che promettente, che pur non raccogliendo consensi unanimi lancia il suo titolare sul proscenio rock-pop nazionale: dal “battesimo” al Parco Lambro del 1975 i concerti fioccano (fondamentali i tour di spalla a Fabrizio De André e P.F.M.), in parallelo all’attività di conduttore dalle frequenze di Radio Milano Centrale, una delle prime emittenti “libere” che in quei mesi nascono come funghi in tutt’Italia. Dal bisogno di una sigla caratterizzante per il programma scaturisce quindi La radio, dinamica e deliziosa filastrocca che da allora è un vero tormentone dell’etere (“L’ho scritta in tram credendo che sarebbe durata due settimane, e invece… Fu Sassi a dirmi di metterla su disco ed è diventata una specie di condanna: è carina, ma non è esattamente la mia cosa della quale vado più fiero”); un tormentone quasi quanto Musica ribelle, la traccia che la precede all’inizio della scaletta del nuovo album Sugoe che certifica il passaggio di Finardi da emergente a stella di prima grandezza (“È una costruzione ideologica, parte da un assunto: non era una canzoncina ma uno sviluppo di Saluteremo il signor padrone. Mi piacerebbe che recuperasse il significato originale invece di essere una sorta di icona che oltretutto ha condizionato la percezione di me: qualsiasi cosa abbia fatto in tutti questi anni, rimango quello della musica ribelle”). Più concreto al paragone con il debutto, ma assai più surreale nella copertina, Sugo esce nella primavera del 1976 e fotografa un artista maturato, circondato da compagni eccelsi (ancora Calloni e in qualche occasione Bullen, ma pure Patrizio Fariselli e Ares Tavolazzi degli Area) e forte di dieci brani più concisi, all’efficacia dei quali contribuisce quel Lucio Fabbri con cui Eugenio divide anche l’alloggio (“Dopo il mio pur relativo successo Camerini si era un po’ staccato da me. Lucio, che oggi è non a caso arrangiatore e produttore, ragiona più in termini di canzoni, e nonostante collaborasse al songwriting meno di Alberto, lavorare con uno con la mentalità alla McCartney mi ha orientato in quella direzione”). Oltre alla sanguigna Musica ribelle e all’aggraziata ma scoppiettante La radio, l’album contiene varie altre perle come le incalzanti Soldi e Voglio (“Un pezzo estremamente mio, molto indicativo della mia attitudine alla musica”), la più leggera ed evocativa Oggi ho imparato a volare (“Per me volo è sempre stato sinonimo di liberazione, anche se il doppio senso con la droga – leggera, però – è fin troppo chiaro”) e la cupa e rarefatta La paura del domani, che sulla scia delle vecchie Afghanistan o Se solo avessicostituisce un brillante esempio di quelle “canzoni educative” assai frequenti nella poetica finardiana. “Ho sempre avuto un senso morale di quel che canto, sapendo che sarà ascoltato. Ho sentito la responsabilità di non essere un cattivo maestro e difatti sono stato anche accusato di moralismo a causa del finalino positivo di parecchi miei testi, che volevo fossero come dei dazebao: immediatamente comprensibili ed emozionali. Adesso, quando interpreto uno di quei brani, mi sento un po’ predicatorio, ma in fondo l’immagine da “preacher” non mi dispiace. Molti miei fan sono migliori di me perché hanno dato retta alle mie parole invece di imitarmi… Senza dubbio ho avuto una vita molto spericolata, ma senza essere mai laido e rimanendo pulito: nelle mie canzoni non ci sono “fai male”, “spara” o “uccidi”, bensì “ascolta”, “ragiona”, “capisci”. Sono contento di avere un’età perché questo mi dà l’autorevolezza di dire certe cose, la stessa autorevolezza che possedeva mio padre – che inevitabilmente porto dentro di me – e la stessa autorevolezza che provavo ad esprimere all’epoca, dato che mi sentivo proprio come adesso”.
Consacrato dall’ultima edizione del Parco Lambro (la Musica ribelle lì eseguita è nel 33 giri-cartolina dell’evento, marchiato dalla Produttori Associati) e da vendite considerevoli, Sugo è seguito nel 1977 da Diesel, che vede all’opera gli strumentisti di sempre (ospiti di rilievo, in due brani ciascuno, il redivivo Camerini e Paolo Tofani – un altro Area – che firma anche la produzione) e vanta un repertorio persino più ispirato ed eclettico. “Considero Diesel, assieme a Sugo, il mio capolavoro: la differenza principale è che questo è più jazz laddove quello era più rock. Rimane però quella che io chiamavo ‘ventosità’, il tempo di Musica ribelle o Voglio: su e giù all’interno di un galoppo, sedicesimi che aiutano a sostenere l’italiano, tensione in avanti. Io volevo qualcosa che avesse lo spirito, la propulsione e la cattiveria del rock ma che fosse italiana nei contenuti e nei suoni: ecco dunque il mandolino o il maggiore con il violino. Pensavo a una musica “nostra” per il mondo, e magari se il progetto della Cramps non si fosse interrotto l’obiettivo si sarebbe anche potuto centrare: l’Italia ha perso il treno proprio in quegli anni, scegliendo la disco music invece del r’n’r”. Come per l’esordio, il recidivo Eugenio apre le danze con Tutto subito, un pezzo tanto energico quanto incompreso (“È un altro dei miei tentativi, fallito miseramente, di essere spiritoso”), e prosegue con altre otto gemme l’una diversa dall’altra nelle atmosfere così come nei temi affrontati: Scuola e Non diventare grande mai appartengono al filone “predicatorio”, Si può vivere anche a Milano è una dichiarazione d’affetto per la propria città (“Quello era un momento vivacissimo: l’estate del ‘76, che si è protratta fino al ‘77, è stata un po’ la “Summer Of Love” milanese, o addirittura italiana”), Zucchero e Non è nel cuore parlano con intelligenza d’amore (“E giù accuse di ‘tradimento’… sono questi i luoghi comuni che non sopporto: Non è nel cuore, come canzone, era persino più rivoluzionaria di Musica ribelle”), la “ventosa” e solenne Giai Phong è incentrata sul Vietnam (“Veniva dalla lettura del libro di Tiziano Terzani. La Storia ha poi dimostrato che la realtà era molto meno romantica e positiva di come volevamo immaginarla, ma non è l’utopia a essere sbagliata: l’idea in sè non ha deluso, lo ha fatto la sua applicazione”). Di livello superiore, almeno sul piano strettamente compositivo, sono infine la jazzata title track, uno splendido omaggio alla vita “on the road” (“È in qualche modo derivata da una canzone sudamericana, Il funerale del lavoratore: il concetto è quello del contadino che ha tutta la sua vita nella terra e quando muore ci viene sepolto dentro. Mi sono così chiesto quale fosse “la terra” del musicista, e ho concluso che era la strada tra un palco e l’altro”) e la drammatica Scimmia, intensissima nel suo crudo raccontare – con il solo limite di una “morale” troppo semplicistica – l’odissea della tossicodipendenza da eroina (“Mi fa tuttora venire i brividi e fatico a sentirla, specie nella parte centrale. Credo che il testo si commenti da solo: è un diario specifico inserito nel più ampio contesto della mia storia personale, una testimonianza molto bella di una cosa che bella non è… soprattutto visto quanti, amici e non, ci hanno lasciato le penne. Col senno di poi, non so se la riscriverei”).
Se Sugo era stato l’album del lancio, Diesel è quello del consolidamento della posizione centrale di Finardi nel rock italiano. Ma non sono, come sembrerebbe, tutte rose e fiori. “Per me non era facile, in quegli anni. Mi hanno danneggiato la macchina sotto casa, ho avuto minacce di morte, per non parlare degli autoriduttori ai concerti: a Padova, roba che a raccontarla oggi rischi di farti prendere per matto, ci hanno persino sparato sul palco. Io non ero preparato, ero troppo giovane: il successo dovrebbe arrivare dopo, verso i trent’anni, quando si ha la maturità per potersi gestire in modo adeguato, come ha fatto Ligabue. Inoltre, c’era il discorso economico: dai tempi della mia prima tournée con Fabrizio De André ero sempre in giro per concerti, e sempre guadagnando pochissimo perché – per questioni di coerenza, di idealismo o di stupidità: era la filosofia di “non guadagno” del giro Cramps – chiedevo la paga di un qualsiasi operaio specializzato. Si calcolavano le ore da quando uscivo da casa a quando vi rientravo, più le spese. Ho fatto date da ventimila persone mettendomi in tasca un milione di lire“. Ad aprire gli occhi a Eugenio e a indurlo a chiedere il giusto sono i ragazzi della sua nuova band Crisalide, ingaggiati dopo che Lucio Battisti si era impossessato di Bullen e Calloni (“Fu la fine dell’originario suono Finardi”): Stefano Cerri al basso, Mauro Spina alla batteria, Ernesto Vitolo alle tastiere e Luciano Ninzatti alla chitarra, con i quali nel 1978 è approntato Blitz. “È un disco che butterei via. Ragionandoci adesso, lì avrei dovuto mollar tutto e fare Anima blues, ma mi è mancato il coraggio”. Troppo impietoso con se stesso, il Nostro, e soprattutto con un album che pur lamentando carenze di “ventosità” e risultando magari eccessivamente pulitino mette in fila otto brani per lo più di pregio, che non a caso verranno in larga parte rielaborati negli anni a venire: brani che nulla aggiungono (e qualcosa tolgono) all’espressività dell’artista, ma che comunque sono considerati tasselli importanti del suo repertorio storico. Affetto e Come un animale danno spazio all’intimismo, la “politica” Cuba gioca con sonorità caraibiche così come la Drop Out Rock in inglese lo fa con le “radici”, Guerra lampo e Op.29 in do maggiore – quasi rimosse, chissà perché, dalla memoria collettiva – uniscono r’n’r più o meno grintoso e “morali”, la Northampton, Genn. ‘78 sostenuta dagli archi è nel contempo una rappacificazione con il padre e un’autoaffermazione della propria raggiunta maturità (“Ero tornato per qualche mese negli Stati Uniti, l’ho scritta lì; all’epoca ci credevo sul serio, mentre ora mi rendo conto che ero molto meno adulto ed equilibrato di quanto pensassi”). E poi c’è la celebre Extraterrestre. “È nata dalla mia passione per la fantascienza ma anche dalla situazione dei miei amici Carlo Massarini e Chicco Martini, che pur essendo dei privilegiati – Carlo abitava in un attico bellissimo, indipendente dall’appartamento dei genitori – erano sempre insoddisfatti e avrebbero voluto trovarsi altrove; è dedicata a chi sogna di essere chissà dove e non apprezza quindi ciò che ha. Strutturalmente era un tentativo di confezionare un hit sullo schema di Musica ribelle, ma non funzionò… è buffo che tutti la ricordino come un clamoroso successo, quando invece Blitz vendette ventiseimila copie: una miseria rispetto a Sugo o Diesel, che a quanto mi risulta – non ho dati precisi – giunsero attorno alle duecentomila. Si erano creati problemi di distribuzione che io imputai a Sassi, con il quale c’erano già tensioni perché non avevo mai visto una lira. Così lui, capendo di non potermi più governare, mi cedette alla Phonogram con tutto il mio catalogo: nelle riedizioni Cramps, infatti, io non ci sono, o ci sono su concessione, perché sono l’unico dell’etichetta a essere stato “girato” a una multinazionale“.
Nel 1979 Finardi consuma così il definitivo “tradimento” con Roccando rollando, presentato con una copertina di dubbio gusto (“La fece Mario Convertino e a differenza di quella di Blitz mi piaceva, la trovavo psichedelica. Alla luce di Anima blues non è nemmeno tanto fuori tema, con quell’idea del cowboy metropolitano…”) ed edificato su sonorità nel complesso più soffici, accompagnate da testi che legittimano accuse di imborghesimento e abiura del passato (eloquenti in tal senso 15 bambini, Lasciati andare e Ridendo scherzando, i pezzi più criticati dai vecchi fan). “È un disco più morbido, volevo fare rock’n’roll ma con un’indole diversa, un po’ come oggi Cremonini o i Negrita. Il mio pubblico, però, era ancora giovane e incazzato, e non poteva accettarlo. Era un periodo particolare: mi ero lasciato con la Elia (la compagna “storica” citata in Non è nel cuore, NdA) e istantanemente era arrivata Patrizia, i musicisti – gli stessi di Blitz – erano più “jazzaroli” e “fusionari”, lo studio Stone Castle di Carimate offriva opportunità eccezionali e io ho sempre amato lavorare sui suoni… e poi le corde vocali erano molto rilasciate, perché i miei problemi di salute si riflettevano anche sulla voce“. Tra i momenti più significativi sono da citare la nostalgica e disillusa Zerbo, la delicatissima Legalizzatela (“Incredibile che ventisette anni dopo sia ancora di attualità. Il discorso sulle droghe è molto difficile, ma credo si debba accettare il fatto che una certa percentuale di esseri umani ha bisogno di assumere qualche tipo di sostanza, ha bisogno di questo tipo di rituali”) e La canzone dell’acqua, elemento che come e più dell’aria ritornerà spesso in futuro: “Il liquido si adatta ma non è comprimibile, non è contenibile se non accettandolo. È una fantastica metafora di come mi sento io: non ha forma ed è aperto a ogni opzione. Sono legatissimo all’acqua: faccio immersioni, vela… Ho anche volato ultraleggero, ma quando si vola l’aria è come un fluido: ho smesso di volare quando ho scoperto le immersioni, perché sono il massimo del volare: il mare è lo spazio e tu sei senza gravità”.
Nel 1979, però, le ali sono tarpate dalle contingenze. “Con la morte di Demetrio, la mia idea di Movimento – quella del Lambro: una visione psichedelico-umanista, e non marxista o militarista, della rivoluzione – poteva dirsi naufragata. Avevo guai personali, subivo contestazioni a ogni concerto, gli anni dell’utopia erano ormai di piombo. Mi sentivo perseguitato, tirare avanti non era facile e io facevo di tutto per rendermelo più complicato”. L’umore di Eugenio è tutto nella prima strofa de La canzone dell’acqua: “Stasera ho chiesto al caso che cosa devo fare / sono stanco del mio ruolo e ho voglia di cambiare / non so se andare avanti o se è il caso di scappare / o se è solo il bisogno di un nuovo sogno da sognare”. Il caso risponderà alla domanda.
(da Mucchio Extra n.19, autunno 2005)
 La questione è semplice: da più parti (Wikipedia, articoli, perfino libri…), Renato Abate in arte Garbo è etichettato come “un esponente della new wave italiana”. Significativo l’incipit della sua voce Wikipedia: “Insieme a Faust’O, ai Diaframma e al primo Enrico Ruggeri, è stato un esponente della new wave italiana, corrente musicale nata nei primi anni Ottanta e ispirata da artisti internazionali come David Bowie, Bryan Ferry, Japan e Ultravox”. Prescindendo dalla castroneria che la new wave italiana sia nata nei primi ’80, chiunque abbia vissuto quegli anni sa bene che pressoché nessuno reputava Garbo “un esponente della new wave” (anzi, e un po’ mi spiace dirlo, i più “duri e puri” lo schifavano, o al massimo lo ascoltavano in segreto); nella sua musica e a volte nel suo look non mancavano elementi che potevano alimentare l’equivoco, ma l’artista milanese – come si riscontra pure nelle sue interviste del 1981, quando debuttò per la major EMI con A Berlino… va bene – non sapeva niente della new wave nazionale e conosceva ben poco quella internazionale, e soprattutto non aveva nulla a che spartire con il circuito più o meno underground della vera nuova onda tricolore. Incasellarlo nella new wave è quindi una vaccata di alto livello (del resto, c’è chi fa lo stesso con Alberto Camerini) oppure, volendo essere indulgenti, un’enorme forzatura storica e giornalistica. Chi non si fidasse del sottoscritto dovrà inevitabilmente prendere per buone le parole del diretto interessato, da me raccolte per una lunga intervista appena pubblicata nel n.39 di Vinile.
La questione è semplice: da più parti (Wikipedia, articoli, perfino libri…), Renato Abate in arte Garbo è etichettato come “un esponente della new wave italiana”. Significativo l’incipit della sua voce Wikipedia: “Insieme a Faust’O, ai Diaframma e al primo Enrico Ruggeri, è stato un esponente della new wave italiana, corrente musicale nata nei primi anni Ottanta e ispirata da artisti internazionali come David Bowie, Bryan Ferry, Japan e Ultravox”. Prescindendo dalla castroneria che la new wave italiana sia nata nei primi ’80, chiunque abbia vissuto quegli anni sa bene che pressoché nessuno reputava Garbo “un esponente della new wave” (anzi, e un po’ mi spiace dirlo, i più “duri e puri” lo schifavano, o al massimo lo ascoltavano in segreto); nella sua musica e a volte nel suo look non mancavano elementi che potevano alimentare l’equivoco, ma l’artista milanese – come si riscontra pure nelle sue interviste del 1981, quando debuttò per la major EMI con A Berlino… va bene – non sapeva niente della new wave nazionale e conosceva ben poco quella internazionale, e soprattutto non aveva nulla a che spartire con il circuito più o meno underground della vera nuova onda tricolore. Incasellarlo nella new wave è quindi una vaccata di alto livello (del resto, c’è chi fa lo stesso con Alberto Camerini) oppure, volendo essere indulgenti, un’enorme forzatura storica e giornalistica. Chi non si fidasse del sottoscritto dovrà inevitabilmente prendere per buone le parole del diretto interessato, da me raccolte per una lunga intervista appena pubblicata nel n.39 di Vinile.
 Ho conosciuto Marco Contestabile, in arte Black Snake Moan, il 17 ottobre del 2019. Suonava a Roma, al Lanificio, e la performance mi folgorò, “costringendomi” a recensire il suo album appena uscito, il suo primo per così dire ufficiale; dell’esordio autoprodotto del 2017 non avevo purtroppo saputo nulla, ma recuperai quella sera stessa. Quello che scrissi del nuovo disco, a inizio novembre, si può leggere qui sotto; non solo confermo tutto, ma rileggendomi mi scopro molto soddisfatto, anche sotto il profilo formale, delle mie parole.
Ho conosciuto Marco Contestabile, in arte Black Snake Moan, il 17 ottobre del 2019. Suonava a Roma, al Lanificio, e la performance mi folgorò, “costringendomi” a recensire il suo album appena uscito, il suo primo per così dire ufficiale; dell’esordio autoprodotto del 2017 non avevo purtroppo saputo nulla, ma recuperai quella sera stessa. Quello che scrissi del nuovo disco, a inizio novembre, si può leggere qui sotto; non solo confermo tutto, ma rileggendomi mi scopro molto soddisfatto, anche sotto il profilo formale, delle mie parole. Phantasmagoria
Phantasmagoria Black Snake Moan, che si è battezzato così ispirandosi a un country-blues di Blind Lemon Jefferson (
Black Snake Moan, che si è battezzato così ispirandosi a un country-blues di Blind Lemon Jefferson (





 (1) In giorni non troppo lontani, il termine “indie” – spesso legato a “rock” – veniva per lo più utilizzato per indicare musica bella e creativa opera di artisti che non avrebbero disdegnato un posto al sole ma che intendevano condurre il gioco secondo le proprie regole. In seguito, a cavallo tra secondo e terzo millennio, il vocabolo assunse significati più ampi, e qui da noi venne di solito associato a gruppi che per lo più cantavano in inglese e proponevano musica ispirata da band americane come Pixies, Sonic Youth e/o Pavement. C’era anche chi adottava l’italiano, ma al di là dell’idioma preferito per i testi le proposte “indie” erano appannaggio di una cerchia ristretta e (più o meno) eletta di appassionati, che ne esaltavano i valori reali o presunti e le innalzavano a sorta di autocompiaciuta antitesi al becero nazionalpopolare. Questo produceva un curioso effetto: tutti gli esponenti della categoria si lagnavano per gli scarsi riscontri ottenuti fuori dal circuito carbonaro, ma se per caso qualcuno riusciva a sporgere il capo oltre il muro del ghetto, su di lui piovevano immancabili accuse di tradimento e meretricio. Situazioni già viste, a conferma di come gli umani siano bravissimi a far finta di non vedere le lezioni della Storia.
(1) In giorni non troppo lontani, il termine “indie” – spesso legato a “rock” – veniva per lo più utilizzato per indicare musica bella e creativa opera di artisti che non avrebbero disdegnato un posto al sole ma che intendevano condurre il gioco secondo le proprie regole. In seguito, a cavallo tra secondo e terzo millennio, il vocabolo assunse significati più ampi, e qui da noi venne di solito associato a gruppi che per lo più cantavano in inglese e proponevano musica ispirata da band americane come Pixies, Sonic Youth e/o Pavement. C’era anche chi adottava l’italiano, ma al di là dell’idioma preferito per i testi le proposte “indie” erano appannaggio di una cerchia ristretta e (più o meno) eletta di appassionati, che ne esaltavano i valori reali o presunti e le innalzavano a sorta di autocompiaciuta antitesi al becero nazionalpopolare. Questo produceva un curioso effetto: tutti gli esponenti della categoria si lagnavano per gli scarsi riscontri ottenuti fuori dal circuito carbonaro, ma se per caso qualcuno riusciva a sporgere il capo oltre il muro del ghetto, su di lui piovevano immancabili accuse di tradimento e meretricio. Situazioni già viste, a conferma di come gli umani siano bravissimi a far finta di non vedere le lezioni della Storia.