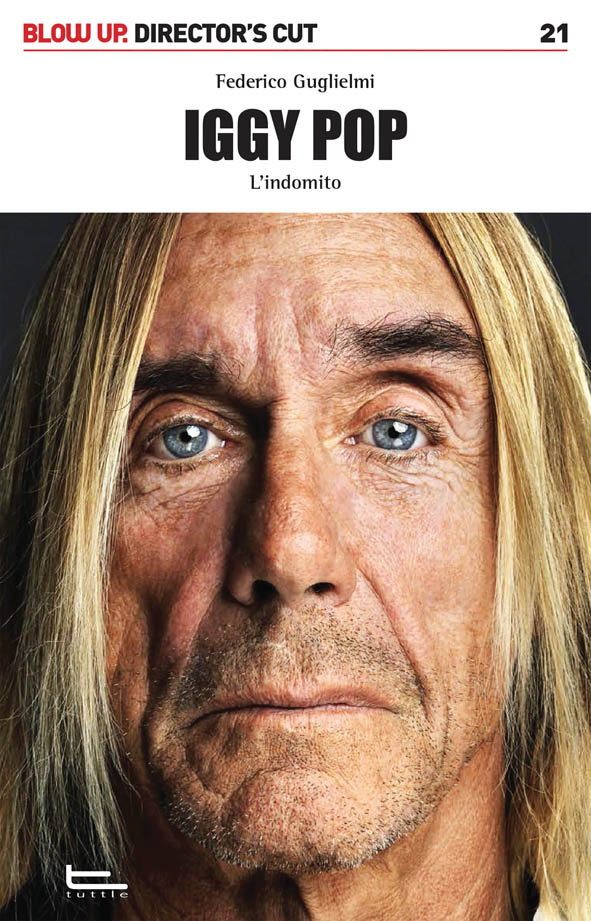Nello stesso giorno di The Downward Spiral dei Nine Inch Nails vide la luce un’altra pietra miliare del rock (non solo) americano (non solo) degli anni ’90, il quarto album dei Soundgarden. Che recensii in tempo reale con queste parole.
 Superunknown
Superunknown
(A&M)
Fanno riflettere, album come Superunknown, su quanto bizzarro sia questo music business che oggi esalta ciò che solo ieri sarebbe stato accusato di obsolescenza. Sui corsi e ricorsi del rock, che (ri)portano ciclicamente in auge fenomeni dati per morti e sepolti e rivalutano personaggi cui un anno prima si guardava al massimo con gelida commiserazione. Su come un bravo artista abbia bisogno, per raggiungere la meritata affermazione, anche di trovarsi al posto giusto al momento giusto, o magari di essere coinvolto – non necessariamente per propria volontà – in un trend in grado di riscuotere attenzioni di massa.
Senza le varie menate su Seattle, sul grunge e sul rock alternativo, i Soundgarden non sarebbero mai approdati alla A&M. Non avrebbero forse inciso Louder Than Love e Badmotorfinger, e sicuramente non avrebbero confezionato un capolavoro come Superunknown. Capolavoro di ispirazione, di equilibrio formale e di intensità emotiva, anche se non di invenzione: troppo stretti i suoi legami con i primi odiati e ora amati Seventies, con i Led Zeppelin, con storie di due decenni fa. A quelle storie, Chris Comell e compagni hanno restituito energia e entusiasmo; senza stravolgerne l’essenza le hanno tirate a lucido, attualizzate, rivitalizzate, generando un manifesto di moderno hard rock tra i più efficaci e affascinanti di questi pur ricchi anni ‘90. Un rock duro che sa essere feroce, idilliaco e visionario. Un rock che urla, geme, gode e ferisce. Insomma, l’asso (di cuori?) mancante perché Seattle veda trasformato in poker il suo tris di Nirvana, Pearl Jam e Alice In Chains.
(da AudioReview n.138 del maggio 1994)




 Mingle With The Universe si può acquistare nelle librerie o
Mingle With The Universe si può acquistare nelle librerie o  Foolish Like The Flowers
Foolish Like The Flowers Vive
Vive Youths Of Age
Youths Of Age