Scoprii i Mudhoney da subito, come del resto era accaduto alcuni anni prima con i loro antenati Green River, e fu amore alla prima nota. Un amore che per dura, tenace, per mille motivi che ho più volte esposto per iscritto. Detto che qui nel blog figurava già un’intervista a Steve Turner, e che la dettagliatissima monografia (con intervista-fiume a Mark Arm) uscita a suo tempo sul Mucchio Extra è disponibile sul sito OndaRock, ripropongo ora questa mia retrospettiva del lontano 1991, quando la band di Seattle aveva appena pubblicato il suo secondo album.
 “Touch Me I’m Sick” – “Toccami, sono malato”: davvero un bello slogan per questi giorni AIDS-fobici – è il titolo del detonante 45 giri con il quale i Mudhoney iniziarono ne1l’agosto 1988 la loro avventura discografica. Il singolo, in tiratura limitatissima come norma Sub Pop impone, scomparve in breve tempo dai negozi; e l’inevitabile ristampa, realizzata dopo che il combo di Seattle aveva già acquisito una discreta notorietà e dopo che il brano aveva conosciuto la meritata gloria grazie alla cover propostane dai Sonic Youth, si distinse anche per la “suggestiva immagine” – un particolare, indovinate voi quale, di una stanza da bagno – ostentata in copertina.
“Touch Me I’m Sick” – “Toccami, sono malato”: davvero un bello slogan per questi giorni AIDS-fobici – è il titolo del detonante 45 giri con il quale i Mudhoney iniziarono ne1l’agosto 1988 la loro avventura discografica. Il singolo, in tiratura limitatissima come norma Sub Pop impone, scomparve in breve tempo dai negozi; e l’inevitabile ristampa, realizzata dopo che il combo di Seattle aveva già acquisito una discreta notorietà e dopo che il brano aveva conosciuto la meritata gloria grazie alla cover propostane dai Sonic Youth, si distinse anche per la “suggestiva immagine” – un particolare, indovinate voi quale, di una stanza da bagno – ostentata in copertina.
Nei tre anni trascorsi dall’uscita di quel malsano inno generazionale a oggi, i Mudhoney sono divenuti uno dei nomi di punta della scena underground statunitense: hanno prodotto un mini-LP, due album e una discreta mole di 7 e 12 pollici, bene accolti dal pubblico (anche europeo) e dalla critica; hanno proposto alle platee di mezzo mondo i loro infuocati live-show, vissuti all’insegna della grinta e della spontaneità; sono stati, nel 1989, il gruppo preferito dai programmatori delle college-radio, e hanno contribuito non poco alla crescita della scena musicale della loro regione e della sua etichetta più famosa, la mitizzata, spesso oltre gli effettivi meriti, Sub Pop di Bruce Pavitt. “Non fatevi ímpressionare da ciò che leggete sulla ‘scuola’ di Seattle: è un’invenzione ridicola, è la stessa storia che si verifica ogni qualvolta dalla medesima zona emergono quasi contemporaneamente due o tre band di una certa levatura. Il luogo in sé non conta affatto, ogni ‘movimento’ va giudicato caso per caso per scongiurare il pericolo che un mucchio di mediocri vadano a rimorchio dei pochi in gamba”. Questa la caustica opinione di Steve Turner, chitarra solista del quartetto.
Sono rimasti “indipendenti”, i Nostri. Non per sfiducia nei confronti delle major, ma perché – volendo credere alle loro dichiarazioni: ma è saggio farlo, visto il tenore abbastanza ridanciano delle interviste? – nessuno si è ancora preoccupato di contattarli, a differenza di quanto accaduto per i loro concittadini ed ex compagni di label Soundgarden. Interessante, al proposito, la teoria del cantante e chitarrista Mark Arm: “I Soundgarden hanno maggiore riscontro perchè sono più fotogenici di noi, e probabilmente questa è l’unica ragione per la quale vendono più dischi dei Mudhoney e sono più appetibili per una multinazionale. Però le cose cambieranno quando la gente ci vedrà dopo l’operazione di plastica facciale”. Facezie. Di sicuro, comunque, i membri dell’ensemble potrebbero trarre un certo giovamento estetico dalla decisione, da qualche mese già passata in fase operativa, di far ricrescere le lunghe chiome imprevedibilmente tosate prima della tournée dell’album di debutto: perché, per quattro ragazzotti anonimi come Mark, Steve, Matt e Dan, affidare le proprie chance di successo alla sola caratura dei brani potrebbe causare spiacevoli delusioni; e sarebbe deprecabile, sul serio, se una band di tale livello rimanesse nell’ombra per non voler assecondare neanche in minima parte le regole forse tristi, ma dalle quali è ormai impossibile prescindere, dell’attuale music-biz. In ogni caso, i responsabili della Sub Pop hanno deciso di non lasciare nulla di intentato, e hanno affidato la promozione dei loro pupilli a un’importante agenzia di Los Angeles (la stessa dei cui servigi hanno usufruito, con eccellenti risultati, gli ora affermatissimi Faith No More); una sfida stimolante, specie alla luce del fatto che il nuovo disco – inciso su un otto piste, stranamente senza la collaborazione alla console del solito Jack Endino – sancisce il ritorno a sonorità ben più ruvide, grezze e abrasive rispetto a quelle (peraltro assai torride) del precedente Mudhoney del 1989.
Every Good Boy Deserves Fudge, una specie di concept incentrato sul tema della ricerca di se stessi, è dunque un album assolutamente istintivo e viscerale, composto e registrato in un brevissimo lasso di tempo con tutti i pregi (rari) della freschezza e i difetti (trascurabili) della carenza di programmazione; quasi un secondo esordio, emblematico soprattutto considerato come le interviste concesse lo scorso anno dalla band dessero pressoché per scontata l’imminenza dello scioglimento. Gli insani propositi non si sono fortunatamente tradotti in realtà, e i Mudhoney di oggi sembrano guardare al proprio futuro con l’aria di chi non crede in improbabili manne dal cielo ma vuol solo proseguire per la propria strada con il minor numero possibile di condizionamenti espliciti e occulti; non curandosi dei trend, che troppo spesso generano mistificazioni, e desiderando solo concretizzare in modo brillante e coinvolgente la propria devozione al rock’n’roll. Creando, ma non cercando a ogni costo di nascondere influenze e riferimenti, come si evince dalle parole di Mark Arm: “Sono cresciuto con l’hardcore, specie con quello californiano: Circle Jerks, Descendents, Black Flag, Germs, Bad Religion… però mi sentivo anche abbastanza vicino alla filosofia dei Minor Threat e delle altre band ‘positive’ di Washington D.C. e poi amo gli Stooges, che sono anche una grande passione di Steve assieme a MC5 e Blue Cheer. Contrariamente a quel che si può pensare, non credo che i Mudhoney abbiano molto a che vedere con i Seventies: la nostra attitudine è molto più marcatamente anni Sessanta, è proprio da lì che abbiamo ‘rubato’ tutte le nostre canzoni”.
Non c’è da stupirsi, quindi, degli stordenti aromi Sixties che esalano da parecchi episodi, a cominciare dalle tenebrose litanie organistiche di Generation Genocide (lo strumentale d’apertura) e Check-Out Time (la superba, conclusiva ballata dalle movenze ipnotiche) per proseguire con Into The Drink, Who Are You Drivin’ Now? e Fuzz Gun ’9l che, non fosse per l’imponenza della sezione ritmica e la “modemità” del1’impostazione canora, si potrebbero quasi ritenere il frutto delle prove in cantina di qualche oscuro gruppo garage-punk di cinque lustri orsono; e non c`è da meravigliarsi neppure della sferragliante fragorosità di Good Enough, Shoot The Moon o Pokin’ Around, che fra una bizzarria e l’altra richiamano alla mente i Sonic Youth, né di Something So Clear e Don’t Fade, che ciascuna alla sua maniera rinverdiscono in chiave delirante antichi furori settantasettini. E giunti al termine del1’ascolto di questo inebriante cocktail di contaminazioni e sinergie – del quale Move Out, semplicemente splendida nel suo mescolare le carte degli stili, rappresenta forse il momento-clou – riesce difficile credere che brani quali Let It Slide e Thorn (due devastanti hard-rock, non a caso editi anche a 45 giri) o Broken Hands (un convulso equilibrismo pacato/dissonante in classica vena Sub Pop, seppur personalizzato da insolite varianti) risultino in definitiva gli episodi meno sorprendenti di un album memorabile. Che fa riflettere su come non si debba mai dare per sicura l’inesistenza di ulteriori percorsi evolutivi – o quantomeno “trasversali” – per quell’imprevedibile mutaforma chiamato rock’n’roll.
Every Good Boy Deserves Fudge travolge e magnetizza, appassionando con le sue atmosfere tribali, i suoi estremismi (moderati, comunque, almeno al raffronto con certe aberrazioni oggi tanto in voga), con la sua vibrante frenesia; e i Mudhoney sono sempre gli stessi di Superfuzz Bigmuff, anche se tra le loro chitarre d’acciaio si insinuano a tratti tastiere e armonica e se il loro originario grunge ha copulato con la psichedelia, il garage e il pop concependo figli bastardi. Anzi, “mutanti”, volendosi attenere al gergo fantascientifico/supereroistico: con un termine che, in questo caso, non va associato a mostruose deviazioni, ma all`esigenza di adattamento agli sviluppi di un mondo sempre più corrotto dal germe del crossover. Buona fortuna, amebe di fango.
Mudhoney: la scheda
Sarebbe naturale, osservando i loro volti ancora imberbi, pensare ai Mudhoney come all’ennesima congrega di giovanissimi alla prima concreta esperienza di gruppo. Beh, la verità è ben diversa: Mark Arm, il cantante/chitarrista, aveva infatti guidato i Green River (due mini-LP e un album, l’ottimo Rehab Doll, al loro attivo), nei quali aveva militato per un certo periodo anche il chitarrista Steve Turner, mentre il bassista Matt Lukin era stato al servizio dei Melvins, tra i primi nella loro area ad aver tentato di coniugare hard, punk e ogni altra forma di rock’n’roIl aspro e rabbioso in una miscela dotata del requisito dell’originalità. Allo stesso modo, però, non è possibile catalogare i quattro di Seattle come musicisti navigati ma senza molta fortuna che decidono di unire le proprie forze solo per confezionare un eventuale prodotto di successo: troppo l’entusiasmo che trasuda dalle loro note, troppa la vivacità ispirativa, troppo pronunciata la loro vena iconoclasta.
L’efficacia della formula Mudhoney è subito dichiarata dal singolo Touch Me I’m Sick e dal mini-LP Superfuzz Bigmuff, entrambi del 1988: un sound graffiante e malato, a volte proteso verso il punk più brutale (Touch Me I’m Sick, No One Has”) e a volte indirizzato verso agghiaccianti “ballate” non prive di riferimenti psichedelici (Mudride, Sweet Young Thing Ain’t Sweet No More), che attraversa anche, è chiaro, tutti i possibili livelli intermedi. Per l’album di debutto i Nostri faranno attendere circa un anno, mantenendo nel frattempo viva l’attenzione del pubblico con un singolo a metà con i Sonic Youth (dei quali interpretano l’allucinata Halloween; sul retro, Thurston Moore e compagni offrono un’esecuzione alla loro maniera di Touch Me I’m Sick) e con altri due ottimi 45 giri, You Got It e This Gift; l’agognato Mudhoney non delude comunque davvero le aspettative, offrendo un suono più raffinato (beh, diciamo meno rozzo) rispetto alle precedenti prove ma sintetizzando alla perfezione il Credo dell’ensemble, basato essenzialmente sulla grinta, sul gusto dell’oltraggio sonoro e soprattutto sulla contaminazione degli stili. Dodici episodi formidabili, tra i quali non si possono non citare almeno Here Come Sickness, un incrocio fra Stooges e Sonic Youth, e By Her Own Hand, un pop infetto. Da qui fino al recente Every Good Boy Deserves Fudge (anticipato dal 45 giri Let It Slide), il quartetto si dedicherà soprattutto ai concerti, limitando le produzioni discografiche a un singolo (Thorn, prodotto da Kent Steedman dei Celibate Rifles; ospite in un brano, Billy Childish degli Headcoats) e ad Hate The Police, un EP di cover pubblicato dalla australiana Au-go-go; visti i frutti della pausa di riflessione, è però difficile che qualcuno abbia il coraggio di lamentarsi della lunga astinenza.
Tratto da Velvet n.10 (Anno IV) dell’ottobre 1991




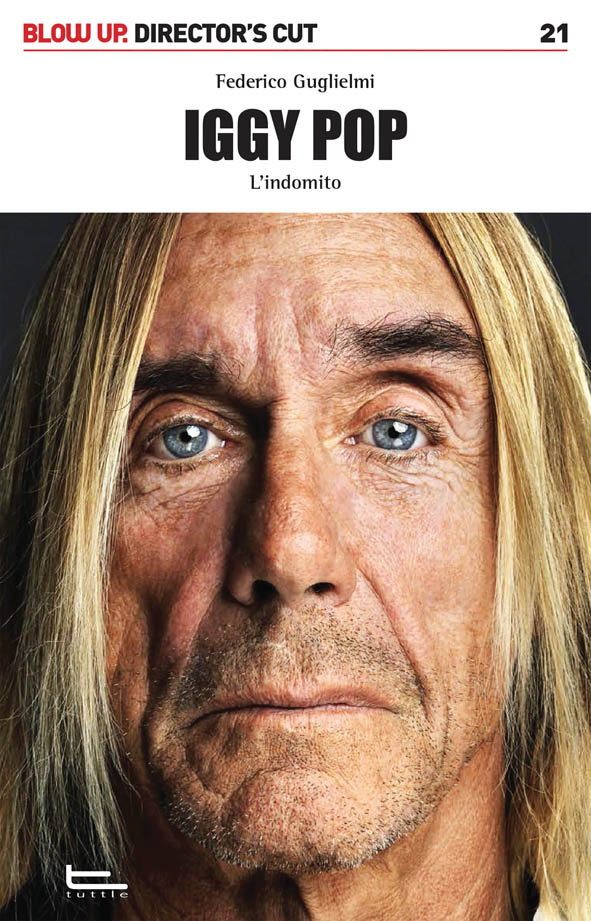













Anche io li amo, ma più per l’approccio al rock ‘n’ roll che per le canzoni. E penso che Mark Arm sarebbe d’accordo, perché, se non ricordo male, dichiarò a Michael Azerrad (dichiarazione poi finita su “Our Band Could Be Your Life”) che i Mudhoney non sono mai riusciti ad andare oltre, dal punto di vista qualitativo, a “Touch Me I’m Sick”; ecco, io concordo con Mark Arm (e come potrebbe essere il contrario? 🙂 ).
Ciò non toglie che li vedrò senza dubbio quando, a metà maggio, passeranno dalle nostre parti in tour.
Come cazzarola fai, muovendoti in quell’ambito, a fare meglio di “Touch Me I’m Sick”? Impossibile! 😀