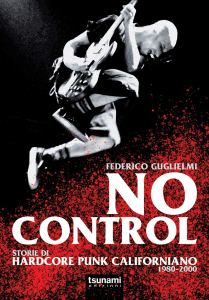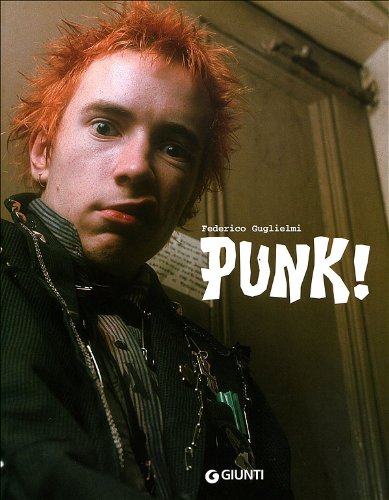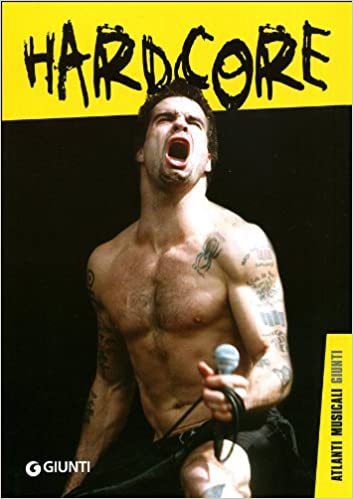Proprio oggi, e non accedeva da un po‘, ho incontrato Stefano Romiti, già chitarrista di quella magnifica band – purtroppo scioltasi da tempo, dopo appena tre album – che rispondeva al nome Elettrojoyce. Inevitabile, visto che non avevo ancora scelto la solita “intervista del lunedì”, recuperare questa chiacchierata di oltre quindici anni fa, quando il quartetto romano aveva appena pubblicato il suo secondo CD. In quella circostanza ebbero persino la copertina del Mucchio, benché “a mezzi” con i La Crus.
 L‘altra canzone italiana
L‘altra canzone italiana
Non sono affatto dei novellini, gli Elettrojoyce, anche se il loro nome è ancora poco noto alla platea nazionale: negli ambienti rock della città che li ha visti nascere, Roma, Filippo Gatti (voce e basso), Andrea Salvati (chitarre e tastiere), Stefano Romiti (chitarre) e Fabrizio D’Armini (batteria) sono però molto popolari, e tutto lascia pensare che l’allargamento a macchia d’olio della loro fama sia solo una questione di tempo; e allo scopo, a seguire al già importante passo dell’omonimo esordio del ‘96, servirà certo l’album Elettrojoyce, per marchiare il quale la Sony ha dovuto vincere la concorrenza di altre multinazionali. Con il gruppo non si è comunque discusso di questioni di mercato, bensì di inclinazioni creative, motivazioni e obiettivi artistici: discorsi seri e circostanziati che, se mai ce ne fosse stato bisogno, hanno confermato lo spessore di un progetto rock personale e affascinante, al quale è davvero il caso di prestare attenzione.
Penso sia più che evidente che gli Elettrojoyce, pur con tutti i distinguo del caso, amino la forma-canzone. Cosa potete dirmi a proposito del vostro approccio?
Al di là di ciò che forse potrebbe anche essere lecito ritenere, i nostri brani non derivano da un procedimento intellettuale ma sono il logico risultato del nostro rapporto personale con la musica: da sempre tutti noi preferiamo i songwriter alle esperienze cosiddette sperimentali, Crosby o Sylvian a Ozric Tentacles o Van Der Graaf Generator.
Mi risulta, però, che la vostra carriera sia iniziata con sonorizzazioni di poesie.
È vero e non c’è da stupirsene, visto che la poesia è una mia grande passione (a parlare è Filippo, NdI). Mi sono avvicinato alla letteratura grazie ai testi di Bob Dylan: mi piaceva leggere quelle piccole storie, e scoprire che i libri di T.S. Eliot o Mallarmé equivalevano agli inserti-testi dei dischi mi ha spinto a creare prima in mente, e poi con il gruppo, la musica più in tema con essi. In seguito, quando abbiamo capito che le improvvisazioni portavano a risultati meno freschi e innovativi rispetto a quelli ottenuti indirizzandoci verso canzoni semplici e definite, abbiamo trovato la nostra strada.
Secondo voi, la canzone deve per forza avere tra le proprie caratteristiche l’immediatezza e la melodia o può anche essere deviante?
Innovazione e devianza sono concetti che hanno valore solo rispetto a una forma di partenza: è difficile dire se sia corretto tentare di stravolgere qualcosa se prima non si è almeno provato a conoscerla ed eseguirla nella sua “classicità”; tutti i maestri dell’avanguardia del primo ‘900, a cominciare da Picasso, erano eccellenti artisti figurativi, ed è iniziando da lì che poi sono arrivati a fare quello che hanno fatto. Spesso l’arte contemporanea ha dato vita a realtà così mutevoli e individuali che molti hanno perso il contatto con la struttura originaria dell’ambito artistico nel quale operano; la sperimentazione musicale ha senso solo se si hanno ben chiari i concetti primari e si decide di divergere da essi, la distruzione di tutte le forme può impressionare al primo ascolto ma è condannata a essere rapidamente dimenticata.
In che modo la vostra nazionalità si riflette sulla musica che eseguite?
Non viviamo il nostro essere italiani come un handicap, ma come una cosa naturale; l’Italia, ma anche la Francia o la Spagna, vantano grandissime tradizioni di scrittura di canzoni, oltretutto dotate di un punto di differenziazione positiva rispetto a quelle anglofone. Crediamo che battere su questo tasto significhi dare una dignità quantomeno storica e artistica a un prodotto. La canzone popolare latina ci affascina con i suoi micro-ritratti, con i suoi piccoli momenti descrittivi intrisi di profondo lirismo anche se a volte un po’ criptici; questa è la tradizione alla quale ci ispiriamo, e ne siamo orgogliosi.
Però vi ispirate, e nettamente, anche al rock.
Vediamo il rock come un’attitudine, come qualcosa che è al di sopra dei singoli orientamenti stilistici; il rock è l’espressione moderna della canzone popolare, e dunque fonderlo con radici anch’esse popolari non è un procedimento astruso. Non siamo neppure d’accordo con quanti effettuano distinzioni tra il rock e la musica leggera: noi definiamo quest’ultima “musica di puro intrattenimento”, perché il rock può restare rock anche essendo leggero: quel che conta è l’emotività del messaggio, la commozione, la fisicità.
E questo, negli Elettrojoyce, come si concilia con l’impostazione lirica estremamente colta e ricercata?
Non c’è contraddizione: lo spunto che vince la sua lotta per diventare canzone possiede sempre una certa immediatezza di impatto, e il tentativo di colpire subito – con un riff e/o con una frase specifica – rimane anche se poi i brani acquistano vari sensi laterali o sotterranei. Il difficile sta nel conservare questa ambiguità in modo coerente, mantenendone in piedi entrambi gli aspetti; qui entra in ballo la ricerca, la capacità di unire il lato fisico e “superficiale” del rock ai riferimenti letterari che nell’iconografia tradizionale appartengono a un’altra sfera. Noi crediamo che possano convivere e prendere forza l’uno dalle altre.
Non rivolgo quasi a nessuno domande relative alle influenze, ma a voi sono costretto a farla perché proprio non riesco a trovare termini di paragone. Gli Elettrojoyce a chi hanno “rubato”?
Nessuna delle risposte che potremmo darti spiegherebbe davvero il suono degli Elettrojoyce; non ci è mai interessato “rubare” alcunché, ma senz’altro assimiliamo qualcosa dagli artisti che amiamo a livello di essenza, di attitudine. Chiarito questo, io (Filippo, NdI) posso indicare come miei “modelli” il David Crosby dei ‘70, tutti i Joy Division e il primo Van Morrison solista, personaggi solo in apparenza incompatibili tra loro, visto che tutti sono accomunati dalla sincerità, dall’onestà, dalla capacità di rischiare anche nel difetto, di portare ogni propria caratteristica stilistica al massimo dell’espressione anche nella nudità; l’insegnamento che ne ho tratto è che se quel che canto o scrivo non è “vero”, “vero” per me, non vale la pena di suonarlo. Tornando ai “padri” degli Elettrojoyce, Andrea nominerebbe Keith Jarrett e David Sylvian per quanto riguarda le tastiere e Neil Young o gli Afghan Whigs per le chitarre; Stefano direbbe The Edge degli U2, prototipo di una chitarra melodica assolutamente atecnica e concentrata nella memorabilità, semplicità e sincerità del riff; Fabrizio, che è arrivato per ultimo e ha quindi dovuto confrontarsi con uno stile già esistente, citerebbe infine la new wave dei primi ‘80, che gli ha trasmesso l’inclinazione per la ritmica funzionale al brano: quella, cioé, che non esce mai dal seminato né ricerca l’attimo di autonomia esecutiva.
Esattamente l’opposto dei gruppi oggi “alla moda”.
Sì, ma non è per antagonismo a priori: la nostra base ritmica, pur essendo molto studiata e – speriamo – emotivamente efficace, è “sacrificata” alla causa della canzone. Come bassista il mio mito, a parte Peter Hook dei Joy Division, è Jimmy Garrison: sosteneva tutte le magie del mitico quartetto di John Coltrane suonando fondamentalmente solo due note.
I testi degli Elettrojoyce, invece, sono meno lineari: passano dal sociale all’intimista, traboccano di citazioni e risultano alla fine un po’ ermetici.
È vero, le mie immagini liriche vantano una maggiore complessità rispetto a quelle convenzionali. In un album tendo soprattutto a focalizzare un concetto base che diventa il fulcro attorno al quale girano le canzoni, e le canzoni subiscono stimoli diversi e non prendono sempre la stessa strada.
Il perno del primo album era la solitudine. Qual è quello di Elettrojoyce?
In estrema sintesi, la creazione del rapporto dell’individuo con la società. Desideravo, pur mantenendo l’ombrosità e il pessimismo che ci vengono istintivi, provare a lanciare un messaggio positivo, un messaggio di speranza sulla possibilità di aggregazione e di risposta al sistema. Ho fondato un po’ tutto sull’idea romantica dei piccoli che sfidano quialcosa di molto più grande e forse anche di incomprensibile. Il nostro è un continuo cambio di piano espressivo tra la quotidianità delle storie di persone comuni e il bisogno di più elevati riferimenti a livello sociale.
Quindi ci sono anche l’amore e il sentimento.
I temi più difficili da trattare senza cadere nell’ovvietà. Lì ho cercato di camuffarmi e di trovare soluzioni poco prevedibili, come in Amanti volanti, il pezzo più apertamente sentimentale: oltre a essere una eroica storia d’amore tra due persone – il cui sesso, tra l’altro, è volutamente non precisato, onde evitare i soliti razzismi da cantautore – si rifà a un libro sui vampiri degli anni ‘70, In fondo al tunnel degli americani Skipp e Spector; gli amanti volanti possono essere due pipistrelli, la nebbia che passa sotto le porte quella in cui si trasformano i vampiri, il sorriso può essere speciale per via dei canini aguzzi.
I tuoi “omaggi” alla letteratura sono frequenti e molto vari: il titolo (Scorrete le mie lacrime disse il) poliziotto, ad esempio, è la fedele traduzione di quello di un romanzo di Philip Dick, che è anche “ringraziato” nelle note assieme a Yeats, Strauss, Blake, Eliot…
Cerchiamo di identificare, in base al nostro gusto, realtà culturali secondo noi più compatibili tra loro di quanto si pensi: non è vero che chi legge Eliot non può amare anche Dylan Dog, o che chi ascolta rock non può apprezzare Brahams. Questi sono i pregiudizi del “potere” al quale noi aspiriamo a dare fastidio: a noi piace l’utilizzo della cultura moderna in maniera frammentaria e libera, non scolastica o accademica.
In questo ti senti più superiore alla massa o più emarginato?
Mi sento uno della massa che ha la possibilità di parlare degli altri, uno che si è auto-eletto rappresentante di una piccola parte di massa. Non mi riesce di sentirmi superiore a un’altra persona, anche se magari posso sentirmi più bravo di un altro artista. Forse, un artista è chi sente di avere qualcosa di meno della gente normale e per tentare di scoprire cos’è parla più degli altri.
Qui a Roma avete fama di essere una band scomoda, che dice sempre ciò che pensa.
Non ci siamo mai sentiti il Gruppo Rock per eccellenza, gli eletti, i rappresentanti del “ghetto d’oro”: abbiamo lavorato sul nostro progetto con coerenza e passione, ed essendo riusciti a svilupparlo in modo autarchico siamo portati a denunciare le situazioni inaccettabili nelle quali ci imbattiamo. Non abbiamo alcun problema quando riscontriamo un impegno e una serietà simili ai nostri, ma se ciò non accade ci incazziamo. Come puoi intuire ci incazziamo abbastanza spesso, ma nessun ragazzo che è venuto a parlarci dopo un concerto potrà mai dire che ci comportiamo da stronzi: accuse del genere possono uscire solo dalle bocche di qualche musicista raccomandato.
La vostra è la logica dei “duri e puri”?
Tutti siamo in qualche modo corrotti dalla nostra presenza nel mondo, ma esiste un grado di onestà al di sotto del quale non si deve scendere: più si riesce a resistere e più si ha la forza di parlare. È da poco scomparso Fabrizio De André: anche lui avrà avuto i suoi scheletri nell’armadio, ma la voce non gli è mai mancata perché le sue scelte artistiche e umane sono state sempre di notevoli coraggio e spessore; è quando si cominciano a fare cose in cui si crede meno, o che addirittura non piacciono, che la voce diventa flebile.
Fino ad oggi, muovendovi in un contesto difficile ma comunque ristretto, siete riusciti a realizzare ciò che volevate. Cosa accadrà adesso che state effettuando il salto di categoria?
Crediamo molto nel concetto di equipe, e per mantenere autonomia e controllo sulla nostra attività stiamo aggregando una squadra di professionisti seri e motivati: dal management della Colosseum all’editore musicale BMG-Ricordi, dall’etichetta Epic/Sony alla produzione – il Jungle Sound di Milano, forse il massimo che un musicista possa desiderare in termini di capacità e disponibilità – che ci ha supportato nella realizzazione di Elettrojoyce.
Se la vostra squadra crescesse sul serio, cerchereste di far qualcosa per la bistrattata scena romana?
Parlarne adesso è prematuro, ma stiamo già studiando un’operazione di sostegno: al di là della tanta gente immeritevole di attenzione, sia tra gli emersi che tra gli emergenti, ci sono tante ottime realtà ancora inespresse o sommerse. Sai cosa ci indigna di più? Che, a parte Renato Zero, nessuno degli affermatissimi e ricchissimi cantautori romani – che oltretutto hanno costruito le loro fortune sul finto impegno politico – abbia mai mosso un dito per creare o sostenere micro o macro strutture che fossero di aiuto ai giovani musicisti.
Seppure nel vostro piccolo, per fare un po’ di promozione alla città ci siete voluti voi, che andate in giro con la Panda carica di strumenti e con un tecnico del suono che lavora gratis quando non avete di che pagarlo.
Non sappiamo se saremo mai in grado di allestire situazioni come la Mescal o il Consorzio, ma è garantito che ci proveremo. Le ragioni che ci spingono, però, non sono umanitarie, ma artistiche: un artista soffre a vivere nel deserto ed è contento se ha opportunità concrete di dialogo, scambio e confronto con altri artisti; un artista invidioso dei suoi colleghi, invece, è proprio un artista di merda.
(da Il Mucchio Selvaggio n.337 del 2 febbraio 1999)
Dove la musica è ancora una ragione di vita (un blog di Federico Guglielmi)