All‘epoca di questa intervista lunga e profonda, AD 2006, non avrei ritenuto possibile che l‘album al quale mi agganciai per realizzarla – L’arcangelo – sarebbe stato il terzultimo di Ivano Fossati, a causa del suo ben noto ritiro dalle scene del 2011. È invece andata in questo modo, e dispiace davvero che un autore e interprete così eccelso taccia mentre un‘infinità di asini e muli continuino tranquillamente a ragliare. Speriamo che Ivano, prima o poi, ritorni sui suoi passi.
Chiaro e forte
Seduto su un divanetto assai più comodo di quanto il suo design antico faccia pensare, nella sala piuttosto austera di un noto hotel capitolino, Ivano Fossati è abbronzato e di ottimo umore, a smentire per l’ennesima volta la leggenda metropolitana che lo descrive meditabondo, chiuso e “secchione”. I modi cortesi e l’attenzione prestata alle domande mettono l’intervistatore a suo agio, e l’accuratezza con la quale – dopo qualche istante di riflessione – articola ogni risposta fa capire quanto voglia essere compreso e mai frainteso: il comportamento tipico, insomma, di chi ha dedicato al proprio progetto comunicativo energie notevoli, e pertanto ci tiene che esso non sia trattato con superficialità. Sarà anche un po’ più “pop” di altri dischi di Ivano, L’arcangelo, ma l’ispirazione che lo ha generato è pura e nobile come l’entità mitica e mistica omaggiata nel titolo… ed è bello averne conferma, parola dopo parola.Credo sia evidente che dopo l’intimismo de La disciplina della terra e l’insolita esperienza strumentale di Not One Word, tu abbia avviato un processo di “apertura” all’esterno che ha trovato sbocco prima in Lampo viaggiatore e adesso, in modo forse persino più compiuto, in L’arcangelo. È possibile spiegare questo tuo cambio di sensibilità e di approccio?
Sono sicuro che la chiave della “svolta” sia nel passaggio attraverso Not One Word, in quel periodo di circa un anno in cui mi sono dedicato solo alla musica. È difficile spiegare il meccanismo, ma forse i miei testi e i miei pensieri erano divenuti troppo carichi, con stratificazioni di significati e a volte persino doppie letture. Istintivamente mi è venuta voglia di liberarmi delle parole, di concentrarmi sulla musica, e tutto ciò mi ha fatto ri-innamorare della voglia di scrivere canzoni in modo più diretto e comprensibile. Non solo per quanto riguarda i testi, ma anche sotto il profilo strumentale.
L’arcangelo è ancora più immediato del suo predecessore: si è trattato di una scelta almeno in parte pianificata, o ti sei limitato ad “assecondare gioiosamente” il tuo istinto?
Hai usato un termine perfetto, ho proprio assecondato gioiosamente le mie inclinazioni. È stato l’album più veloce della mia carriera, quello che ho impiegato di meno ad approntare: una sola estate invece dei consueti due o tre anni, e i brani sono praticamente così com’erano alla prima stesura. Non è però una questione di nuova energia, bensì di metodo rinnovato: mi sono accorto subito che funzionava e che lasciava molto più “leggero” anche me, meno stanco e anche più entusiasta. Passavo da una canzone all’altra con una sorta di sentimento giocoso, per certi versi inedito.
Mi chiedevo se questa spinta all’apertura – continuiamo a chiamarla così – sia stata da te avvertita più a livello sonoro o più a livello verbale.
Per me i due aspetti marciano in parallelo, non riesco a comunicare dei pensieri senza che la parte musicale sia il più possibile in sintonia con tali pensieri. Suoni e parole devono parlare la stessa lingua: quindi, se ho un’intenzione di tipo letterario, la accompagno a una stessa intensità musicale. In queste canzoni, almeno per come la vedo io, è difficile operare una scissione fra testi e strutture sonore.
Il processo di concepimento delle canzoni è avvenuto in ambienti diversi dal consueto?
Sono state quasi tutte composte viaggiando. Dopo l’ultimo album dal vivo, per un buon annetto non mi sono mai messo a scrivere: non avevo idee, e anzi mi domandavo dove sarei andato a parare.
Già… se non aspettavi almeno tre anni, se non cinque, che gusto c’era?
Ma sì, sono un po’ pigro, non è un mistero. Improvvisamente, dopo un viaggio a Cuba, riflettevo sul fatto che avrei volentieri collaborato con qualche percussionista locale: da questo interesse per le loro tecniche è nato l’embrione musicale de L’arcangelo, che però aveva anche bisogno di essere sostenuto da qualche parola. Così ho preso qualche foglio di carta e sono subito venute fuori le prime strofe della title track, ma non mi sarei mai aspettato che da lì in poi tutto il resto sgorgasse in modo tanto rapido, ma sempre viaggiando. Dovunque fossi, ogni volta che avrei dovuto avere poco tempo o avrei dovuto essere distratto, trovavo nuovi stimoli, e questo flusso di brani non si arrestava. Con mia grande gioia, come puoi immaginare.
Il risultato discografico di questa spontaneità potrebbe però essere male interpretato, anche a causa della grazia delle melodie e della ricchezza degli arrangiamenti: qualcuno, insomma, ti potrebbe rivolgere accuse di “commercializzazione”.
L’ispirazione è ispirazione, e non ci si può far nulla. Ogni disco ha il suo passo, le sue caratteristiche, e in questo caso io sentivo di poter andare in questa direzione: mi divertiva, mi interessava, e inoltre non avevo dubbi che le storie che mi premeva raccontare attraverso i testi necessitassero di questa veste musicale. Tra un anno potrei forse essere pentito delle mie decisioni, ma a mio avviso quel che conta è il momento della scelta.
Ma a Ivano Fossati importa di quel che si dice e scrive di lui?
Meno di un tempo, quando ero più timoroso dei giudizi su di me e la mia musica. Oggi ho imparato che ciò che più conta è fare quello in cui si crede, essendo però pronti non solo agli elogi ma anche alle critiche: io sono prontissimo, non mi aspetto che le cose vadano sempre per il verso giusto, che le persone siano d’accordo con me artisticamente o che il pubblico non possa essere spiazzato. Ma non posso forzare la mia natura musicale.
A proposito, ma questa produzione “rock”… si può dire, no?
Ma certo che si può! Mi è venuto da sorridere constatando come alcuni tuoi colleghi avessero quasi paura di pronunciare la parola, come se il tormentone di Celentano l’avesse resa sconcia. Come accennavo prima, le mie canzoni nascono già caratterizzate, e già quando abbiamo fatto una sorta di pre-produzione si capiva cosa sarebbe accaduto; poi, però, c’è stata l’idea di affidare il timone a due giovani, Pietro Cantarelli e mio figlio Claudio. Se me ne fossi occupato io sarebbe stato più patinato ed elegante, e credo che a quest’album non avrebbe fatto bene: loro, invece, hanno optato per soluzioni più potenti, rauche, ruvide, a mio avviso più adatte a queste parole.
Ecco, le parole: da dove arrivano tutti i riferimenti religiosi presenti nelle liriche?
Credo che gli uomini sentano l’esigenza di avere da un lato una guida, quale che sia, che sta in alto, e dall’altro qualcosa su cui scaricare le responsabilità. È un bisogno antichissimo, e figurati se questi nostri giorni così pieni di confusione, problemi, conflitti, non amplificano la necessità. Gli angeli dei quali parlo nel disco sono poco tratteggiati, ognuno li identifica come vuole: il primo pezzo ha per protagonista un tale che, in una specie di avamposto costruito da lui, aspetta l’angelo della speranza, ma che angelo sia non lo specifica; certo, dice l’angelo di dio, ma è un dio che sa solo lui, non lo spiega. L’album è in effetti ricco di simbologie di questo tipo, alcune legate alla religione in senso stretto e altre più libere, ma il denominatore comune è il desiderio di qualcosa di soprastante, il desiderio di non essere soli.
Da brani come Ho sognato una strada o Cara democrazia, però, emerge anche un deciso “sentire” politico, paragonabile a quello di un tuo classico come La canzone popolare.
Sì, è vero, ma in questo caso il sentimento politico è più ampio, più alto, direi sovranazionale. Un sentimento politico-sociale, un’attenzione che abitua me come autore e magari anche gli ascoltatori a una visione, ripeto, sovranazionale. Non possiamo più permetterci di guardare soltanto dentro i nostri confini, è ora di rivolgere sempre più spesso lo sguardo fuori, cosa alla quale noi italiani siamo purtroppo poco abituati. Nelle canzoni de L’arcangelo vedo l’indole ad affacciarsi all’esterno.
È casuale che un disco così esplicito veda la luce in questo preciso momento, con le elezioni alle porte e il dibattito politico abbassato ormai al livello di gazzarra da mercato?
Con questa domanda vuoi sottintendere che si tratta di una strategia, ma devo deluderti: è casuale. Un pezzo come Cara democrazia l’avrei fatta uscire un anno fa o – purtroppo, credo – tra due anni. Ho scritto un album, l’ho inciso e diffuso sul mercato: concomitanza e contemporaneità con questi avvenimenti non sono cercate, ma ovviamente non mi sottraggo alla responsabilità che, cadendo proprio in questo periodo, l’album possa suscitare riflessioni e discussioni.
E tu la avverti, la tua responsabilità di “predicatore” di sani principi?
La sento sempre, anche quando scrivo una canzone d’amore. Qui in Italia siano abituati all’idea che certi autori debbano scrivere solo pensieri sensati: come diceva Fabrizio De André, bisogna stare attenti anche al più piccolo degli aggettivi, perché le sciocchezze rimangono e i ragazzi ci credono. Dovrebbe essere insito nel mestiere di chiunque pubblichi non necessariamente un disco ma qualsiasi altro pensiero, sotto forma di film o libro.
Sì, però la musica è uno strumento più potente, perché può arrivare senza bisogno che la si cerchi.
Lo so. Infatti non si può essere superficiali, o almeno io non riesco a esserlo. So benissimo quello che faccio.
Quindi a tuo avviso la canzone non ha perso la sua funzione educativa?
La può avere, questa funzione. A lasciarmi perplesso, semmai, sono i risultati. Però, sulle intenzioni, non ho da recriminare: se penso a tanti anni di canzoni italiane composte da miei colleghi devo ammettere che di sforzi ne sono stati compiuti parecchi. Qualche risultato l’avremo pure ottenuto, no?
Mi viene da pensare a Il battito, che sembra una preghiera a puntare in ogni cosa a una maggiore profondità: è davvero questo?
Sì, questa è una parte del discorso. L’altra, se vogliamo più specifica, è legata alla sintesi quotidiana alla quale siamo obbligati: se dobbiamo ragionare e parlare sempre più velocemente, se dobbiamo fare il nostro mestiere sempre più velocemente come la vita e la tecnologia odierna ci chiedono, il mio timore è che assieme alle parole si accorcino anche i pensieri. È un po’ come dire che svanisce la capacità di articolare i pensieri e spingerli in profondità, cosicché a volte, più che di capire una cosa, ci si chiede di intuirla; oppure, perché lo fanno tutti, usiamo termini derivati dalla tecnologia o da lingue straniere senza conoscerne realmente il significato. È così che lentamente sbiadisce il corpus di quella che continuiamo a chiamare cultura, un’altra parola che si va svuotando dall’interno. Come dico spesso, mi auguro di non invecchiare parlando a impulsi: nel brano io ipotizzo, ovviamente metaforizzando, un domani in cui la comunicazione è un colore o, appunto, un battito. Io cercherò di ribellarmi, ma non so quanti altri lo faranno.
E dunque il fatto che vuoi essere ricordato “come un glaciale geroglifico / come un bassorilievo / come un graffito inesplicabile / perché del tutto inutile” vuol dire…
…che siccome ho pensato in esteso e scritto in esteso risulterò obsoleto, inesplicabile, inutile, anche in quanto semplice autore di canzoni e non filosofo. E dunque voglio essere lasciato lì. Logicamente sono ironico: il senso è “mi accontenterò, e voi altri andate pure avanti a comunicare, chessò, con il codice binario”.
La vena fortemente ironica è comunque piuttosto presente nel disco: penso a Reunion (Cha Cha Cha) e La cinese.
Con mia felicità, sì. Ci sono argomenti che forse risultano più efficaci se trattati in questo modo. È la lezione gaberiana: temi importanti, anche importantissimi, affrontati con sferzate di giocosità e ironia, eppure perfettamente comprensibili perfino nella loro drammaticità. Con Giorgio ne sorridevamo e contemporaneamente ne soffrivamo.
La cinese, nella quale – mutatis mutandis – mi sembra di rilevare affinità con la poetica di Rino Gaetano, è fra l’altro più o meno un reggae.
Un reggae che non dovrebbe esserci ma che, in giro per il mondo, c’è. In questo momento esistono tipi musicali che per fortuna non vengono dagli intellettuali, dall’alto, ma dal basso, dalla strada, in un continuo mescolarsi senza regole. Dopo avere teorizzato per anni, a tavolino, la contaminazione in quanto espressione culturale e intellettuale, sono molto più contento adesso nel riscontrare una bella contaminazione di taglio basso, fatta in modo istintivo e senza progettualità, ma molto divertente.
Denny è una canzone sull’omosessualità, ma la questione è sviluppata con estrema delicatezza.
L’intento era scrivere una canzone d’amore che non si potesse definire una canzone d’amore “diverso”. Non importa chi sono i due protagonisti, perché si amano e come si amano: conta che questo amore possa essere cantato. Era da un bel po’ che volevo provare a dire la mia su questo argomento oltretutto ora come ora – altra coincidenza – molto “caldo”, ma ci tenevo a farlo con mano molto leggera, evitando il rischio che dalle parole trasparisse una diversità e quindi una discriminazione. Non è stato semplice, e infatti questo è il pezzo che mi ha portato via più tempo a livello di ricerca della chiave giusta, prima, e di rifinitura del testo, poi.
La disposizione nella scaletta degli undici brani è come un percorso che va dal generale al più individuale: è corretto?
Sì, ma è venuta da sé. Quello del montaggio del disco è un’operazione delicata, perché la sequenza – con i suoi passaggi, le sue pause, le sue rincorse – suggerisce anche significati ulteriori. Lavorandoci mi sono reso conto che questa era la stesura che mi piaceva: una partenza con riflessioni più dure ed esplicite seguita da uno spostamento verso una distensione personale, anche con qualche sberleffo e sorriso, fino alla serenità conclusiva.
Ci tenevi a non lasciare l’amaro in bocca.
Sì, volevo chiudere con positività, con una specie di piccolo decollo. Penso con terrore a un album che iniziasse pesantemente e terminasse con pari pesantezza, sarebbe un messaggio troppo duro; in questo momento c’è bisogno solo di messaggi sensati.
Come prevedi la resa live de L’arcangelo?
Attinente al suono del disco, e quindi mi aspetto di divertirmi e sudare un po’ di più. Magari anche recuperando canzoni accantonate perché poco in linea con il repertorio più intimista che portavo sul palco.
Tornando al discorse delle elezioni, è mai capitato che qualche partito ti abbia offerto di candidarti nella sua lista? In fondo in parlamento è finita un mucchio di gente che con la politica non aveva nulla a che spartire.
No, fortunatamente se ne sono ben guardati: se capitasse, non potrei fare altro che rispondere con un cortese rifiuto. Non è il mio mestiere: se avessi voluto fare il politico avrei cominciato quando avevo vent’anni e forse oggi lo sarei pure, un politico… ma io voglio fare il musicista e proseguire la mia vita facendo solo questo.
Mi chiedevo se questo tuo desiderio di “apertura” si rifletterà anche in una maggiore presenza televisiva, un medium con il quale tu non hai mai avuto un rapporto idillico.
Mah, di solito faccio quello che mi suggerisce il mio gusto, e ritengo che questo spieghi perché, in generale, mi si vede abbastanza poco. Non credo che mi darò maggiormente, è una cosa che non mi viene. Ti dirò di più: se dovessi accorgermi che L’arcangelo funziona più del solito, e che quindi lavora per me, cercherei di trattenermi in misura ancora superiore. Sarei pienamente felice se l’album sostituisse la mia presenza fisica.
Tratto da Il Mucchio Selvaggio n.620 del marzo 2006





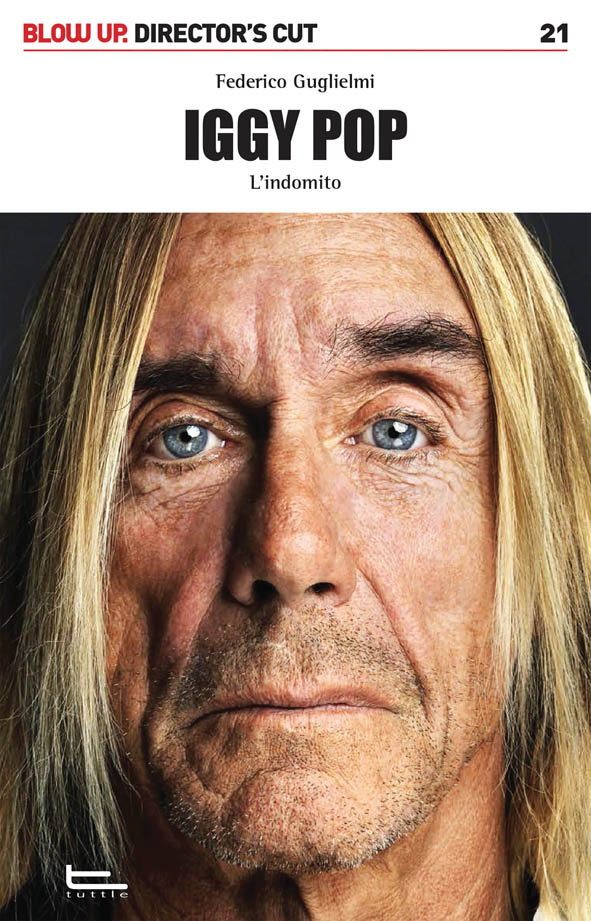













Non hai del tutto torto. Avevo incontrato Ivano un altro paio di volte, in precedenza, e quindi mi conosceva già in qualità di intervistatore. Era particolarmente desideroso di spiegarsi perché, mi disse, il collega che mi aveva preceduto aveva esordito con “scusami, Ivano, ma non ho avuto tempo di ascoltare il tuo nuovo disco, puoi parlarmene tu?”, cosa che aveva trasformato quella che doveva essere un‘intervista in un mesto monologo. Succede anche questo, nel bestiario: gente che va a fare interviste (con uno come Fossati, poi!) senza conoscere l’argomento del quale si dovrebbe discutere…
Se avessi avuto un figlio lo avrei chiamato Ivano, non per Ivano bensì per Ivanhoe, ma se qualcuno avesse pensato che l’avessi chiamato Ivano per Ivano non mi sarei irritato, affatto! E tanto più dopo aver letto questa intervista.
Cauntriboiorellando: pare proprio che Ivano abbia abbassato il ponte levatoio sul fossato che circonda il suo castello e ti abbia fatto entrare con tutti gli onori, sedere alla sua tavola, e tu sazio e satollo e rimontato a cavallo ne sia poi uscito, più sereno e soddisfatto come capita sempre ad un cavaliere dopo un felice incontro con un altro cavaliere.