Domani, 14 maggio, sarà ufficialmente disponibile Vivid, il nuovo album di Beatrice Antolini: un disco di svolta nella carriera dell’eclettica artista marchigiana, che almeno secondo logica dovrebbe accrescerne la già discreta popolarità. In tal senso, un valido contributo fu quello offerto dal Mucchio nel 2008, quando la proposi come “cover star” in occasione dell’uscita del suo secondo lavoro, A due. Una scelta della quale non sono affatto pentito.
 Non è un’artista sperimentale, non è una rocker, non è una cantautrice… o, meglio, è tutto questo assieme, e molto altro. L’abbiamo incontrata in studio non solo per ascoltare con largo anticipo il suo secondo album, atteso per ottobre, ma anche per fare quanto più possibile luce sul più insolito, enigmatico, affascinante “nuovo” talento della musica italiana.
Non è un’artista sperimentale, non è una rocker, non è una cantautrice… o, meglio, è tutto questo assieme, e molto altro. L’abbiamo incontrata in studio non solo per ascoltare con largo anticipo il suo secondo album, atteso per ottobre, ma anche per fare quanto più possibile luce sul più insolito, enigmatico, affascinante “nuovo” talento della musica italiana.
* * *
Il Bombanella Studio si trova in cima a una collina a metà fra Modena e Bologna. Per raggiungerlo ci si imbatte in cartelli che indicano località come Maranello e Zocca, noti alle cronache sportive o musicali, prima di imboccare la strada piena di curve che si inerpica in salita e quindi il viottolo sterrato che – dopo aver attraversato una piccola boscaglia – si spalanca su uno spiazzo dove sorgono una casa colonica e una stalla. È in quest’ultima che Davide Cristiani ha allestito la sua bottega musicale all’insegna del binomio tecnologia & vintage, ed è sempre lì che Beatrice Antolini ha in pratica vissuto dieci mesi, a cavallo tra il 2007 e il 2008, per realizzare il suo secondo album, quello che dovrebbe elevarla da fenomeno underground a fenomeno assoluto. Insomma, il posto migliore per assaggiare in anteprima il disco, ancora in fase di completamento, e per incontrare la ventiseienne marchigiana, che ci accoglie inguainata in un abitino leopardato adattissimo per esaltarne le physique du rôle di “personaggio”: con la katana in pugno sarebbe perfetta per la parte di un’antagonista di Uma Thurman nel terzo Kill Bill, ma potete star certi che se Quentin Tarantino – ma pure David Lynch – ne ascoltasse qualche canzone, le affiderebbe senza esitazioni una colonna sonora.
“La mia musica ha senza dubbio qualcosa di cinematografico”, osserva Beatrice, “ma soprattutto ritengo sia molto visionaria, adattissima a trasportare con la mente da qualche altra parte. Non mi stupirei se un regista mi chiedesse qualche mio pezzo: molti di essi, specie quelli del nuovo disco, mi paiono perfetti per accompagnarsi a storie e immagini”. Impossibile non essere d’accordo, mentre dalle casse scorrono, l’una dietro l’altra, le versioni semi-definitive – le voci sono quelle “di prova” e il mixaggio è approssimativo, ma c’è ugualmente di che restare intrigati e allucinati – degli undici brani di A due, che singolarmente sono quadretti policromi e bizzarri e tutti assieme vanno a costituire un surreale collage all’insegna dell’eclettismo più sfrenato e deviato. Un approccio del quale la nostra interlocutrice è fiera, così come di un disco che, fin dal titolo, è per lei carico di significati. “È come dire ‘Antolini 2’, ovvero il mio secondo album, ma i rimandi sono numerosi: alle iniziali del mio nome, A e B; al fatto che è stato registrato da due persone, Davide e io; all’ottava di pianoforte dalla quale spesso nascono i miei pezzi. E poi, in inglese, si traduce con ‘una cosa dovuta’: dovuta a me stessa ma non solo, poiché vedo la mia vita come una sorta di debito verso altri musicisti. Non so come mai abbia elaborato questa idea così pesante, ma è una cosa che mi sento addosso: devo impegnarmi al massimo per saldare il mio debito verso qualcosa che scoprirò chissà quando o che magari non scoprirò mai“. È positivamente “esaltata”, Beatrice, e quando si tratta di spiegarsi è un fiume in piena. “Riporta pure al concetto di doppio… allacciandosi alle teorie di Antonin Artaud, la musica è il doppio che ciascuno ha dentro di sé. Mi hanno definita, in senso buono, schizofrenica, per via di quelle che sembrano differenti personalità, ma il punto è che mi piacciono talmente tante cose… Devo gestire tutti i miei modi di essere, le troppe cose che faccio e che vorrei fare, e a volte non riesco a starmi dietro. In quest’album c’è tutto quello che l’ha generato, cioè le esperienze e i cambiamenti di vita affrontati da quando avevo ventiquattro anni a oggi, crescendo e confrontandomi con realtà diverse. Di sicuro è un album più importante del precedente, più vissuto a livello interiore… anche perché è il primo concepito per essere tale, mentre Big Saloon era, in fondo, una specie di raccolta di demo finita su CD”.
Già, Big Saloon: l’esordio di Beatrice, pubblicato con il marchio Madcap Collective nel 2006 e piazzatosi secondo – dietro I Am The Creature dei MiceCars – al decimo Premio “Fuori dal Mucchio”. Un disco con una lunga storia alle spalle. “Ho iniziato a suonare prima che a leggere. A casa c’erano strumenti, e mio padre è appassionato di rock degli anni 50 e 60… Ascoltare ogni giorno Michelle dei Beatles è stato un imprinting fondamentale. Così, poiché già da piccolissima componevo canzoncine che proponevo alle mie amichette, i miei genitori mi hanno fatto studiare pianoforte, e l’altro mio riferimento è diventato Mozart. Attorno ai quattordici, quindici anni, dopo un lustro di esami e concorsi, ho avuto una grandissima crisi: la musica classica e il liceo anch’esso classico al quale mi ero iscritta mi assorbivano troppo, e allora ho lasciato il pianoforte e cambiato scuola. Nel frattempo, istigata da alcuni miei coetanei, mi ero messa ad ascoltare rock, a cominciare dai Nirvana: in breve mi sono trovata a suonare la batteria in un gruppo stile Joy Division, per poi improvvisarmi bassista/cantante in un duo industrial. Nel 2000, dopo il diploma, mi sono trasferita da Macerata a Bologna e per me è stata una tappa-chiave, perché vivendo in una città piccola rimani piccolo. Lì ho frequentato per due anni una scuola di teatro e ho pure lavorato come attrice in una compagnia. La musica, però, premeva troppo, e dunque mi sono presto trovata con un paio di cassetti pieni di demo. Ho esitato un bel po’ prima di sottoporli a qualcuno, perché volevo essere convinta che il materiale avesse un valore: non ero sicura, ho il problema psicologico che le cose non mi bastano mai”. Su questo nessun dubbio, come dimostrato dalla scheda di studio di A due, che mostra come in ciascuna traccia vi siano decine e decine di sovraincisioni: un’ossessione, per certi versi, ma anche il naturale sviluppo di una passione che arriva anch’essa da lontano. “A me non interessa solo suonare, ma anche tutta la fase successiva che serve a definire il modo in cui quello che si è suonato viene fuori. Infatti, in quest’ambito, sto cercando di imparare sempre di più: credo di essere più brava come arrangiatrice e produttrice che come musicista. Da ragazzina, del resto, mi divertivo molto provando pseudo-sovraincisioni con un registratorino a cassette: è un istinto che ho sempre avuto”. Istinto che le è rimasto, a giudicare da come le sue mani si muovono rapidamente fra i pulsanti e i cursori del mixer a caccia di migliorie nella resa di un impianto strumentale composito e imprevedibile del quale – come per Big Saloon – è in pratica l’unica responsabile. “Il 99% dell’album è farina del mio sacco. Solo in un pezzo, WJ, sono ospiti Paolo Mongardi alla batteria e Luca Cavina al basso, che oltre a essere la sezione ritmica dei Transgender mi accompagnano dal vivo; in altri due brani, poi, ci sono rispettivamente un sassofonista e un trombettista: ho dei limiti con i fiati… ho cercato di fare da me, ma in sostanza non emetto alcun suono. C’è tutta la mia evoluzione, in A due, partendo da Pop Goes To St. Peter, che è quasi un’outtake di Big Saloon, fino a A New Room For A Quiet Life, un po’ alla Talking Heads, che è il brano più in linea con ciò che sono adesso, dato che sto attraversando un periodo in cui il ritmo mi attrae più della melodia. Non è un concept ma un disco con svariete personalità, che accosta tantissimi generi e non ha un’unità armonica ma solo una coerenza intellettuale. Molti mi dicono che faccio troppo, ma che vuol dire? So di essere prolissa negli arrangiamenti, negli strumenti utilizzati, negli effetti, nelle sovrapposizioni. C’è chi crede che io traffichi con l’elettronica, e invece le mie trame sono solo elettriche o acustiche: nessun campionamento. Risentendo A New Room o Taiga quasi non credo di essere io a suonare tutta quella roba, e l’effetto è straniante. Non sono egocentrica, incontro solo difficoltà a trovare collaboratori di cui fidarmi. Ma la questione è pratica, oltre che di fiducia: avendo una certa padronanza di tanti strumenti, faccio prima e sono più tranquilla a pensarci da me piuttosto che perdere tempo ed energie a spiegare a un altro cosa vorrei che facesse”.
Da pochi minuti Beatrice ha firmato l’accordo con la Urtovox, che spedirà A due nei negozi il 17 ottobre: una scelta, quella indipendente, in piena sintonia con la natura “alternativa” del progetto. “Qui in Italia le cose un minimo articolate sono percepite come ‘difficili’, mentre all’estero c’è maggiore ricettività verso proposte un po’ fuori dai canoni classici: Björk o Beck, per citare due nomi, fanno spesso musica non immediatamente fruibile, eppure in tutto il mondo sono fenomeni anche commerciali. Non vedo il mio stile come ‘di ricerca’: punto alle canzoni, e che in esse confluiscano poi tante cose anche stravaganti che mi piacciono è un’altra faccenda. I miei sono pezzi da quattro minuti che volendo si possono pure canticchiare, non sono mica suite minimaliste. In un certo senso, io sono molto all’antica, e come modelli ideali vedo tutti i grandi della musica del passato: dai Beatles ai Pink Floyd, dai Talking Heads a Neil Young, da Stevie Wonder ai Queen. Magari prima o poi farò un disco all’insegna della libertà totale, ma non adesso”. La “libertà totale”, però, viene di sicuro applicata ai testi, rigorosamente in inglese. “Si adatta benissimo alla mia esigenza di trovare le parole che stanno meglio con la musica, e non è un caso che a volte le ‘forzi’ nella pronuncia e nell’accento: la voce è un altro strumento che detta la linea principale dei brani, e infatti quando compongo – accennando le melodie in una lingua inesistente – il testo arriva sempre per ultimo. Sia chiaro, so benissimo ‘di cosa parla’ ogni mia canzone, ma il significato è qualcosa di molto personale che probabilmente nessuno all’infuori di me comprende appieno. D’altronde io scrivo di me stessa: non mi sento preparata a dibattere di politica o di massimi sistemi, né ho pretese letterarie o poetiche“. Il concentrarsi su di sé non scade tuttavia in una sorta di “autismo” espressivo, come si evince dai concerti. “All’inizio suonavo essenzialmente per me, ed è per questo che i miei cassetti scoppiavano di provini: quando poi ho deciso di aprirli, quei cassetti, è scattato il desiderio suppongo legittimo di dare agli altri qualcosa di me. Il fatto curioso è che, prima, preferivo di gran lunga scrivere-arrangiare-suonare-registrare-produrre, ma dopo un paio d’anni di live mi sono dovuta ricredere e ho capito che i momenti in cui sto meglio, liberata dalle angosce totalizzanti della fase creativa, sono quelli che vivo sul palco, come presentazione e rappresentazione di ciò che sono: il bello è che non provo alcuna tensione, tutto mi viene totalmente naturale… e addirittura, quando non mi esibisco, mi capita di avvertire la mancanza di quel tipo di sfogo”. Un’attività, quella dal vivo, che nonostante le anomalie (o proprio per quelle?), ha contribuito all’esaurimento della prima tiratura di Big Saloon (poi ristampato in versione rimasterizzata e con copertina differente) e a propagandare le peculiari qualità di Beatrice non solo all’interno del circuito indie, come documentato da un articolo di due pagine apparso su “Panorama” nelle prime settimane di quest’anno. “Avevo collaborato con i Baustelle e Bugo, avevo conosciuto Cristina Donà, e casualmente tutti e tre avevano fatto il mio nome al giornalista come personaggio ‘nuovo’ meritevole di essere tenuto d’occhio, e così… È buffo che non sia mai finita su ‘Blow Up’ o ‘Rumore’ e che invece sia stata presa in considerazione da una rivista di grande tiratura: ok, è stato fortuito, ma forse incasellarmi nell’indie è un limite. Meno male che non mi curo di dove mi collocano e mi preoccupo solo di andare avanti al meglio per la mia strada, anche se non so quel che ci sarà dietro la prossima curva. Penso al futuro, ma per me il presente e quello che sento di dover dire ora sono talmente forti che il pensiero non è paragonabile alla necessità. Perché per me la musica non è solo una passione ma un bisogno“.
È sincera, Beatrice, glielo si legge negli occhi. E lo è anche quando, con lo sguardo corrucciato, esterna qualche motivo di disappunto. “Essere una ragazza mi ha un po’ penalizzato. Sembra assurdo, visto quant’è anacronistico, ma regna un’incredulità di fondo sul fatto che una donna sia in grado di autogestirsi come faccio io: il primo istinto impone di credere che dietro ci sia qualcun altro – di sicuro un uomo – che fa le cose o come minimo dice come farle. Io sono sola, e accorgermi che la gente non crede a questa mia polivalenza – nonché ai sacrifici che faccio per coltivarla – mi lascia un bel po’ di amaro in bocca. Per quanto sia anacronistico, mettere in dubbio la posizione di una persona solo perché di sesso femminile rimane un problema culturale”. In effetti, c’è stato chi ha frainteso Big Saloon solo perché in esso era coinvolto come ospite Marco Fasolo, di cui Beatrice era oltretutto, all’epoca, la compagna; si spera che l’equivoco non si ripeta con A due, dove Mr.Jennifer Gentle è corresponsabile del mixaggio. “Marco mi capisce perché, seppure con modalità diverse, fa in pratica quello che faccio io: ho visto nella sua musica degli aspetti di me e lui ha trovato qualcosa di sé nella mia. Collaborare con lui è un piacere e un onore, ma i miei dischi sono scritti, prodotti e suonati da me: quindi, a ognuno il suo“. Essendo la definitiva emancipazione in dirittura d’arrivo – assistendo a una performance, sullo spessore della ragazza non si possono nutrire più dubbi – a Beatrice resta un sogno. “Lavorare con la musica – perché è un lavoro, e a volte anche parecchio duro – con la tranquillità economica di poterlo fare, e sempre più come dico io. Mi piacerebbe avere una casa, in campagna perché non amo molto la città, attrezzata con uno studio per registrare in pace: perché così è una fatica, tra sbattimenti, stress, carenza di tempo e soldi. A premermi di più, comunque, è l’essere riconosciuta come professionista”. Assolutamente legittimo. E A due, al di là di quelle che potranno essere le sue vendite nel breve termine, è un album che potrebbe aprire molte porte. Anzi, buttarle giù. A colpi ben assestati, ma con grazia tutta femminile, di suoni e visioni.
Beatrice Antolini: un manifesto? “La musica per me è una cosa serissima, la cosa più seria della mia vita, anche se poi, è ovvio, mi ci diverto. Se i miei pezzi sono gioiosi, è perché riflettono i momenti nei quali sono stati composti e incisi. Non mi faccio tanti problemi, mi lascio trasportare. Big Saloon è pieno di stranezze – posacenere, bicchieri, roba di ogni genere – anche perché ho dovuro fare di necessità virtù e usare quello che potevo rimediare. Pure in A due mi sono fatta prestare tanti strumenti, ma ho lavorato con una maggiore consapevolezza che non mi ha impedito di continuare a cercare il suono destabilizzante: a priori non voglio precludermi alcuna opportunità creativa”.
(da Il Mucchio Selvaggio n.650 del settembre 2008)





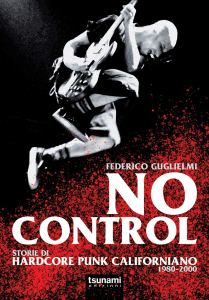




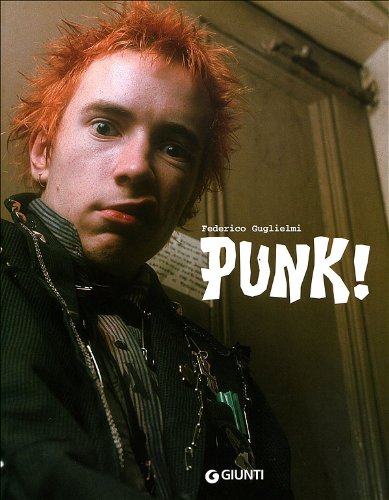




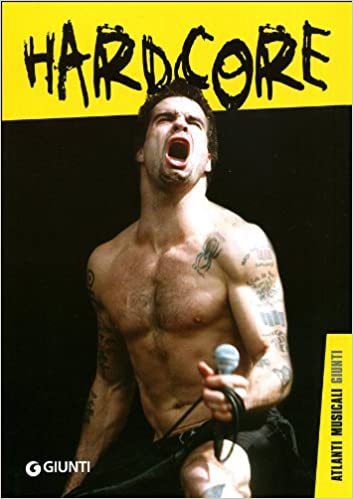


l’ho scoperta grazie a te (che mi facesti scoprire carmen consoli) e ho tutti i cd. mi dovrebbe arrivare vivid a giorni. un abbraccio forte. mi firmo col nome ma sono quello a cui procurasti un biglietto autografato dalla carmen nel 1998… filippo