È notizia di poche ore fa che un’ampia selezione di giornalisti ha eletto Hai paura del buio? degli Afterhours album indipendente più importante degli ultimi vent’anni di musica italiana. Non è certo una sorpresa, ma un ulteriore di quanto il disco sia radicato nell’immaginario collettivo. Quando lo ebbi fra le mani, con qualche settimana di anticipo sulla data di uscita, ne fui impressionato al punto di scrivere una delle recensioni più “sbilanciate” della mia carriera: recensione che Manuel Agnelli ha sempre indicato come la più bella che abbia mai ricevuto, e che non a caso è l’unica riportata per intero nel libretto del primo dei due dvd che anni fa raccontarono la storia del gruppo. Un mese più tardi Manuel, Giorgio e Xabier finirono – naturalmente – sulla copertina del Mucchio, all’epoca settimanale, e finirono anche su quella di Rumore: senza nulla voler togliere alla fondamentale semina del precedente Germi, il loro primo disco con i testi in italiano, la scalata degli Afterhours alle più alte gerarchie del rock nazionale è partita proprio allora, nell’autunno del 1997 (l’album fu pubblicato il 20 ottobre). Questi furono i miei contributi alla nobile causa.
 Hai paura del buio? (Mescal/PolyGram)
Hai paura del buio? (Mescal/PolyGram)
Si può credere nei miracoli? Indipendentemente dalle convinzioni di ciascuno, la nascita in questa pur prolifica Italia musicale di un genuino talento rock come Manuel Agnelli fa certo propendere per una risposta affermativa. D’altronde, se il Cristo verbalmente flagellato in apertura di album ha visto la luce in una stalla in quel di Betlemme, perché negare la possibilità che un nuovo e ben più incazzato redentore possa esser stato partorito – tanto per rimanere in tema – all’ombra della Madonnina?
È cresciuto, Manuel, e dopo un cammino tortuoso e quasi mai agevole durato oltre dieci anni – il suo primo 45 giri, My Bit Boy, è infatti del 1987 – ha raggiunto la maturità. Sfuggendo alle trappole degli Erode, ai tradimenti dei Giuda e alle ancore di salvezza offertegli dai Ponzio Pilato ha arricchito giorno dopo giorno il suo bagaglio di esperienze, di suoni, di sofferenza e di rabbia, continuando a predicare un Verbo che purtroppo non sono stati finora in moltissimi a comprendere. Ha offerto la sua carne e il suo sangue, immolandosi più volte in riti tormentati e feroci. E ha gettato i suoi semi – i suoi germi? – nella terra arida, convinto che prima o poi avrebbero generato frutti rigogliosi.
Hai paura del buio? è tutto ciò che avremmo sempre desiderato dagli Afterhours: un album capace di allontanare i mercanti dal Tempio, di aprire le acque del Mar Rosso, di abbattere le troppe torri di Babele. Un album nel quale credere e nel quale identificarsi nonostante – proprio per? – le inevitabili contraddizioni, gli eccessi, le bizzarrie, gli angoli bui e gli spigoli acuminati. Un album, soprattutto, di grandi e grandissime canzoni, estreme e/o stralunate finché si vuole ma finalmente compiute. Brillanti. Spesso geniali, a dispetto di uno stile ispirato da modelli come i Nirvana e le più diverse gioventù soniche ma sviluppato con un estro, uno spessore e un carattere – nel cantato e nelle liriche, del tutto personali, come negli intrecci degli strumenti, all’insegna della contaminazione più selvaggia e visionaria – che in nessun caso possono esser derivati da calcoli a tavolino.
Urla e geme, Manuel Agnelli, ma sa anche ridere e divertirsi. Aggredisce e ironizza, regala pugni di gommapiuma e carezze al vetriolo, veste i panni di Caronte per traghettare all’Inferno tutti i bravi bambini, uccide le anime con il suo pop catastrofico e non smette di turbare il sonno di chissà quante cristine. Conquista con melodie tra l’ipnotico e l’apocalittico, dosando alla grande crudezza e velluto (sotterraneo), disperazione e gioia, furore (tanto) e leggiadria (poca). E inanella un incredibile numero di potenziali hit alternative che vantano titoli surreali e atmosfere da brividi, a cominciare dalla cupa 1.9.9.6. per proseguire con le devastanti Male di miele (la Smells Like Teen Spirit autoctona?), Dea, Veleno e Sui giovani d’oggi ci scatarro su, con la torbida Punto G o con l’onirica (ma non sognante) Senza finestra, il tutto tra chitarre rumorose, parole ruggite, ritmi pirotecnici e uno splendido, inquietante violino. È Manuel, non c’è dubbio, l’ultimo Messia: un Billy senza boria, una Courtney senza attributi femminili, un Eddie senza aureola, un Kurt senza fucile. Veneratelo oppure crocifiggetelo, ma non fate a meno di ascoltare almeno qualche passo del suo Vangelo.
(da Il Mucchio Selvaggio n.277 del 14 ottobre 1997)
 Tutti i colori del buio
Tutti i colori del buio
Se rock significa ancora istinto, divertimento, poesia (più o meno) maledetta e disturbo della quiete pubblica, Hai paura del buio? degli Afterhours è senz’altro uno dei più grandi album di rock italiano di tutti i tempi. Ora abrasiva e ora torbidamente onirica, ma sempre ispiratissima nelle sue inquietanti fantasie post-nirvaniane, l’ultima fatica della band guidata da Manuel Agnelli – il cui organico è completato da Xabier Iriondo e Giorgio Prette – è infatti una delle più geniali e suggestive dimostrazioni di come la vera attitudine rock, al di là dell’inevitabile ricorso a citazioni, riferimenti e omaggi a modelli esteri, sia ormai patrimonio anche della nostra scena musicale. O, almeno, di una sua parte, quella stessa che da ora in poi non potrà non considerare l’ensemble milanese come uno dei suoi imprescindibili cardini e celebrarlo di conseguenza. Quello che segue è il sunto di quasi due ore di chiacchierata con Manuel Agnelli al tavolo di un bar del quartiere romano di San Lorenzo, complici uno splendido pomeriggio autunnale, tre chinotti e altrettanti bicchieri di vino.
Affrontiamo subito un argomento scomodo: che significato si deve attribuire alla bestemmia posta in apertura di album?
È una provocazione. In un certo senso è il manifesto del disco, che io definirei come un “concept temporale”: le canzoni non si sviluppano sullo stesso argomento né parlano dello stesso personaggio, ma fotografano un lasso di tempo che ha caratterizzato la vita di tutti noi. Volevamo iniziare in modo forte ma anche ironico, come mi pare che emerga dal contesto della canzone: nulla di veramente preciso, solo un grido liberatorio e un’ironia al limite del grottesco.
Anche una presa di posizione contro i falsi moralismi?
Sì, possiamo dire di sì. L’Italia è sempre stata molto ipocrita nel rappresentare la morale e la forma, e Hai paura del buio? vuole essere contro la forma, contro l’esteriorità e soprattutto le distanze che la forma crea. La religione non c’entra nulla, un livore antireligioso non ha senso per chi, come me, ritiene di essere una persona profondamente spirituale. Non sono cattolico, ma credo in Dio… e penso che Lui, se esiste davvero, ha di sicuro più senso dell’umorismo di tanti suoi rappresentanti.
Immagino che il titolo e la copertina vogliano ribadire il medesimo principio.
È chiaro: l’immagine della ragazza da reclame con la scritta “Hai paura del buio?” posta sul viso mira a essere destabilizzante, a insinuare dei germi nella mentalità della gente.
Ancora germi? Quelli dell’album precedente non sono bastati?
Scherzi? Lo scopo principale degli Afterhours è proprio quello di far nascere dei dubbi nella testa di qualcuno. Conosco tante persone, soprattutto a Milano, che sono convinte di viver bene perché la loro esistenza è regolata praticamente, quando sono invece soggette a frustrazioni mostruose. Il buio più grande è il non voler vedere la realtà, e il nostro piccolo ruolo è quello dei tarli, che scavano.
Questo contrasta con la funzione di diversivo dal quotidiano che tanti attribuiscono alla musica: semplice intrattenimento, e non riflessione o addirittura elevazione dello spirito.
Le due cose non possono essere divise: anche il pensare può costituire un diversivo, specie in tempi come questi in cui se n’è persa l’abitudine. Però non ci piace la seriosità e, al contrario, cerchiamo di sdrammatizzare certi concetti: miriamo a essere sempre positivi, a creare un’atmosfera di reazione. Il nichilismo non ci interessa affatto.
Dunque c’è un messaggio.
Sì, il nostro scopo è la comunicazione. Tendiamo a contaminare il prossimo e ad esserne contaminati, ad alimentare il discorso. Riteniamo che pensare sia contagioso e, quindi, vogliamo contagiare.
Credi che sia un obiettivo raggiungibile, specie considerando la dilagante superficialità culturale del pubblico?
Tutto ciò che diventa “di massa” – politica, musica, religione – perde almeno una parte delle sue componenti essenziali per scivolare in qualche modo nel grottesco. Per quanto riguarda il pubblico, non penso che i giovani d’oggi siano più frivoli di quelli, per esempio, degli anni ‘70, che pure sono considerati un’epoca di grande coscienza collettiva: anche allora c’era moltissima superficialità, sia nel dire che nell’affrontare certi argomenti. Magari era più facile nasconderla, mascherarla.
Tu, comunque, rimani un prodotto dei criticatissimi anni ‘80.
Ho avuto la fortuna e contemporaneamente la sfortuna di crescere in un periodo di passaggio, in cui la reazione al caos dei ‘70 è stata l’apatia assoluta, il rifiuto di qualsiasi impegno. È stato terribile, ma mi ha aiutato in fretta a capire quello che non volevo assolutamente essere e mi ha spinto a reagire.
E se gli Afterhours diventassero un fenomeno “di massa”?
Sinceramente spero che questo non accada mai, in quelle condizioni è quasi impossibile mantenere l’integrità, la spontaneità, lo scambio con il proprio pubblico. Preferirei, invece, non oltrepassare di molto il livello di “successo” che ho raggiunto oggi: è un momento ricchissimo di stimoli artistici, che non derivano solo dallo scrivere canzoni ma anche da ciò che ti succede e dai contatti con il mondo che ti circonda, e sono riuscito a realizzare ciò che desideravo fin da quando ho iniziato, cioé vivere dignitosamente della mia musica senza subire troppe pressioni. Purtroppo è molto difficile che una situazione del genere rimanga stabile: o si cresce o, più probabilmente, si muore.
Di solito i gruppi si sciolgono per questioni di donne o di ego.
Per le donne non c’è problema, visto che fortunatamente abbiamo gusti completamente differenti. Per l’ego, invece… non so, credo che gli Afterhours siano abbastanza maturi, e ritengo di essere stato fortunato – visto il mio carattere piuttosto difficile – a trovare persone che riescono a coabitare con me in modo così fruttuoso ed esaltante.
Litigate mai in maniera selvaggia?
Il fine ultimo è ben chiaro a tutti, e fra di noi si è ormai creato un incredibile feeling: dal punto di vista musicale e ideale, visto che gli Afterhours sono un progetto pensato oltre che suonato. Litighiamo spesso, sì, ma credo che il confronto sia indissolubilmente legato ai nostri processi creativi.
L’impressione che si ricava dall’esterno non è quello di una vera e propria band ma quella di un solista con i suoi accompagnatori.
Almeno da tre anni a questa parte, gli Afterhours sono tornati a essere un vero gruppo, e tra Xabier, Giorgio e io si è creata una sorta di magia: un fatto singolare, considerando la nostra estrema diversità di abitudini, personalità e caratteri. Sotto il profilo musicale, però, ci troviamo alla perfezione: è vero che io scrivo la maggior parte dei brani, che raccolgo più soddisfazioni dirette e che la mia esperienza mi fa muovere più facilmente tra i meccanismi del business, però è altrettanto vero che gli Afterhours, senza i miei due compagni, non sarebbero gli stessi. Sono musicisti di grande spessore, non bisogna dimenticare il loro fondamentale contributo all’album di Cristina Donà o quello che Xabier sta facendo con i Six Minute War Madness.
Loro come vivono questa condizione di relativa sudditanza?
Secondo me in modo adulto, nel senso che ognuno conosce i suoi compiti per far funzionare al meglio il progetto. Non è mai successo che Xabier sia venuto a dirmi “voglio fare io questa intervista” o che Giorgio abbia voluto cantare un pezzo, sanno bene che è normale che chi da sempre rappresenta gli Afterhours continui a farlo. In fondo non ho mai creduto nei gruppi troppo democratici, avere tutti lo stesso peso costituisce una terribile autolimitazione.
A proposito di limiti: ai tempi di Germi hai deciso di abbandonare l’inglese perché vedevi troppo circoscritti i tuoi orizzonti di comunicazione?
Sì, ma si è trattato anche di un compromesso, visto che tutto è nato dalla cover di Mio fratello è figlio unico che dovevamo interpretare per il tributo a Rino Gaetano. Il risultato mi ha così entusiasmato che mi sono convinto ad accettare la sfida con l’italiano, con la creazione di un nuova formula dove la lingua doveva essere adattata, sviluppata e incastrata con sonorità ad essa aliene.
Ascoltando Hai paura del buio? si direbbe che ormai ci riesci alla perfezione.
Ti ringrazio del complimento, ma ammesso che questo sia vero sono in ottima compagnia. Molti nuovi artisti stanno portando avanti questo tipo di lavoro, e l’intera scena ne ha guadagnato moltissimo in termini di personalità: ora è finalmente possibile parlare di rock italiano e non, come sarebbe stato più giusto fino a pochi anni orsono, di rock fatto in Italia.
Perché da noi, per combinare qualcosa di serio in ambito musicale, bisogna avere trent’anni?
In generale perché, al di là del naturale gap che deriva dal vivere alla periferia dell’Impero, abbiamo bisogno di più tempo per maturare: le contaminazioni, le collaborazioni, le strutture non sono adeguatamente sviluppate, e quindi per raggiungere determinati traguardi anche minimi ci servono cinque anni invece dei due dell’estero. Tutto è vissuto con il contagocce, ma per fortuna da un po’ di tempo a questa parte i processi stanno subendo una certa accelerazione.
Però dall’Italia escono comunque pochi veri personaggi rock, capaci di imprimere a fondo il loro marchio sul panorama ufficiale.
I musicisti “alternativi”, da noi, devono essere produttori, curare personalmente le pubbliche relazioni, preoccuparsi di ogni aspetto pratico. Tutto, anche la propaganda, è molto contenuto, schiacciato, senza la platealità che accompagna lo stesso genere di situazioni in Inghilterra o in America, e questo ha anche risvolti negativi sulla creatività, visto che tale “compressione” ostacola la diffusione di concetti estremi o comunque di profondità superiore. Chi è nel giro da anni ha probabilmente capito che solo osando si può scardinare il sistema, e dunque tanti trentenni che ne hanno piene le palle di vegetare nella mediocrità azzardano qualcosa di più. O almeno ci provano, piuttosto che decidere che non vale la pena di continuare a sbattersi e trovare un lavoro normale, officina o banca che sia.
In definitiva mi sembri abbastanza ottimista.
Quasi tutti i gruppi in attività da tempo stanno raggiungendo la cosiddetta maturità, e il livello di conoscenze tecniche e professionalità, anche da parte degli addetti ai lavori, si è alzato enormemente. Ho invece un po’ paura del fatto che le giovanissime generazioni di musicisti hanno poca voglia di rischiare: i riferimenti sono troppo precisi e il risultato sono tante copie-carbone di modelli esteri. Una decina di anni fa, invece, le band italiane avevano più voglia di essere personali, anche se magari non ci riuscivano. Vorrei veramente avere vent’anni, per godermi “da ragazzo” tutto quello che sta succedendo: c’è una scena che sta nascendo e un atteggiamento che si sta modificando giorno dopo giorno, e la cosa è molto eccitante.
Secondo te, come si conciliano gli artisti over 30 e un pubblico di giovani dai quindici ai venticinque anni?
Non posso parlare per i colleghi, ma posso assicurarti che io, nonostante i miei trentun anni, mi sento molto più in sintonia con i ragazzi di oggi che con i ventenni che venivano ai concerti degli Afterhours quando avevo la loro età. È un dato inconfutabile, il pubblico è cresciuto sia come mentalità che come numero.
È vero che le vendite globali sono quelle che sono, però il fatto che i C.S.I. siano arrivati in testa alle classifiche è un dato significativo.
È un segnale bellissimo, molto importante per chiunque voglia proporre musica al di fuori dei soliti cliché. Per fortuna dietro questo exploit ci sono altri gruppi “forti e duri” che pur non raggiungendo le primissime posizioni si affacciano in modo abbastanza deciso sul mercato ufficiale. E poi c’è il discorso dei concerti: oggi gli Afterhours possono contare su un’audience tra i cinquecento e i duemila spettatori e su cinquanta/cento date all’anno davanti a un pubblico vero, che ci conosce e canta le nostre canzoni: anche se le vendite dei dischi lasciano a desiderare, il rock italiano non è comunque più una faccenda d’elite.
I CD costano troppo, e parallelamente aumenta a dismisura il fenomeno delle cassette registrate a casa.
È inevitabile. Io, però, lancerei un messaggio provocatorio: fatevi le cassette di quegli artisti stranieri che certo non hanno bisogno di ricevere quattro soldi in più dell’Italia, e comprate il prodotto nazionale. Magari pochi ci pensano, ma la posta in gioco è alta: il potersi porre di fronte al grande giro è uno stimolo molto forte a migliorarsi, e non c’è più quel senso di appagamento, provinciale e deprimente, per avere ottenuto tre recensioni e avere venduto il proprio disco ai propri sessanta fan.
Io non ho mai creduto granché alle cose fatte “per l’Arte”, ma ho sempre pensato che ogni musicista desideri che la sua musica sia venduta.
È così. Ci possono essere scelte alternative alla grande industria, come quella di autoprodursi e autodistribuirsi al 100%, ma non conosco artisti che abbiano deciso di optare per la completa autarchia avendo una concreta opportunità di legarsi a una multinazionale. Sarei felice di incontrare qualcuno che, per questioni ideologiche, ha rifiutato un contratto vantaggioso. Questo, sia chiaro, non significa che certe proposte vadano automaticamente accettate, ma solo che molti – parlo di chi si definisce “militante” e gode di distribuzione major – sono stati ipocriti, o semplicemente non sono riusciti a rimanere fedeli ai propri principi originari.
Il music-biz è pieno di tentazioni. Secondo te, qual è la formula migliore?
Probabilmente essere legati a un’etichetta più o meno indipendente e cedere licenze e distribuzione a una multinazionale. In questo modo si riesce a lavorare in modo abbastanza libero e a mantenere il giusto controllo sulla propria musica avendo il massimo – almeno in teoria – per quanto riguarda la circolazione dei dischi. Il che, mi sembra, è quello che stanno facendo i C.S.I. e quello che stiamo cercando di fare noi, prima con la Vox Pop e adesso con la Mescal.
Peccato che la Vox Pop abbia chiuso i battenti.
Sì, è proprio una disdetta, specie se si considera quanti gruppi oggi in voga abbia “scoperto”: oltre a noi, Casino Royale, Ritmo Tribale, Africa Unite, Sottotono, Prozac +, Mau Mau, La Crus… una vera e propria schiera. Purtroppo da noi è molto difficile operare al di fuori dei soliti circuiti, come provato dalla carenza di etichette indipendenti: è un problema di capitali, di strutture, di esperienza, e spesso il tentativo di sfondare – o almeno di competere con i colossi della discografia – si traduce quasi sempre in una débacle commerciale anche con prodotti potenzialmente appetibili.
Hai paura del buio? è una raccolta di grandi canzoni. Confrontandolo con Germi, ti accorgi di quanto quest’ultimo fosse un po’ confuso, per non dire incompiuto?
L’idea di suono è rimasta più o meno la stessa, ma nel frattempo è successa una cosa molto importante: molti mesi fa, anche se la cosa si è concretizzata solo ora, Mina ha deciso di interpretare in un suo album la nostra Dentro Marilyn. Questo ci ha fatto capire definitivamente che gli Afterhours potevano fare vere canzoni e ha eliminato ogni residua remora sull’opportunità di approfondire questo aspetto della nostra espressività; ora anche gli esperimenti vengono sviluppati in forma di canzone, cioé in un qualcosa che sta in piedi seppure eseguita solo con chitarra e voce. La produzione e gli arrangiamenti rimangono estremisti, certo, ma la differenza sostanziale tra Germi e il nuovo album è che ora i brani sono più maturi a livello di strutture e le sperimentazioni non sono limitate agli episodi più marginali ma abbracciano l’intera scaletta.
Visto che stiamo parlando di canzoni, qual è il significato di Sui giovani d’oggi ci scatarro su?
Milano è una città piena di contraddizioni, anche se per certi versi può essere interessante e stimolante. È un posto dove gli alternativi più estremi sono gli architetti, cioé gente con una base culturale molto borghese. A Milano la forma è molto importante – non a caso è la capitale della Moda – e tutto ciò ci fa veramente schifo perché crea distanze, falsità e ipocrisie che viviamo quotidianamente e nelle quali anche noi, a volte, non riusciamo a non cadere: è in questo senso che noi, sui giovani d’oggi, ci scatarriamo su.
I vostri fan come la prendono?
Sono tutti contenti, la cantano in coro… Si vede che nessuno si riconosce nel giovane d’oggi che va “il sabato in barca a vela e il lunedì al Leoncavallo”. A Milano il 90% dei ragazzi è così, se non nella pratica almeno nelle aspirazioni, e dunque mi meraviglia un po’ che gli Afterhours peschino il proprio pubblico solo nel rimanente 10%…
Hai mai pensato a Male di miele come alla Smells Like Teen Spirit del rock nazionale? Lo stesso feeling adolescenziale, gli stessi arrangiamenti un po’ stralunati, lo stesso ritornello esplosivo…
No, veramente no. Mi fa piacere che parecchi la vedano così, ma per quanto mi riguarda ci trovo più i Pixies – forse il gruppo più geniale del rock moderno nella contaminazione tra melodia pop ed estremismi di arrangiamento – che non i Nirvana. Comunque il fatto che il testo sia in italiano significa che gli Afterhours hanno ormai una propria dimensione, senza dubbio riconoscente a questo o a quel modello ma ormai svincolata da essi.
Come vedi, in prospettiva, la parabola del gruppo? Se questo deve essere il disco del lancio e il prossimo quello del consolidamento, avrai raggiunto il successo a trentacinque anni.
Non è un problema anagrafico, ma di stimoli. È ovvio che faccio fatica a immaginarmi a cinquant’anni a torso nudo su un palco, ma mi auguro che, nell’eventualità che ciò accada, riesca ad avere una parte anche piccola della credibilità di Iggy Pop. Il futuro? Non mi pongo il problema, ma ritengo che la chiave di tutto sia avere la necessità di esprimere qualcosa e non farlo solo perché è bello o trendy. E poi mettersi sempre in discussione, molti grandi risultati si fondano proprio sul non essere mai contenti… e in quest’ultimo campo, non lo nego, sono davvero un maestro.
(da Il Mucchio Selvaggio n.281 dell’11 novembre 1997)





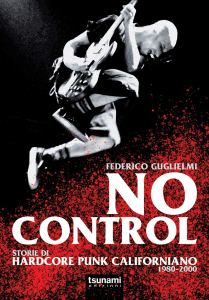




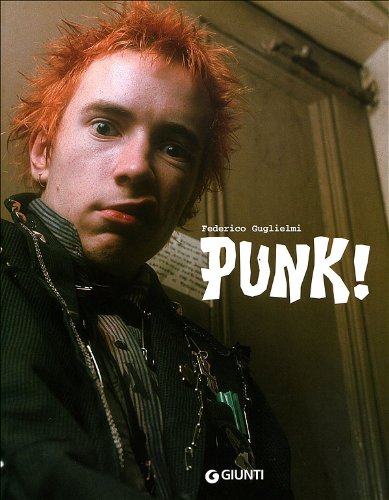




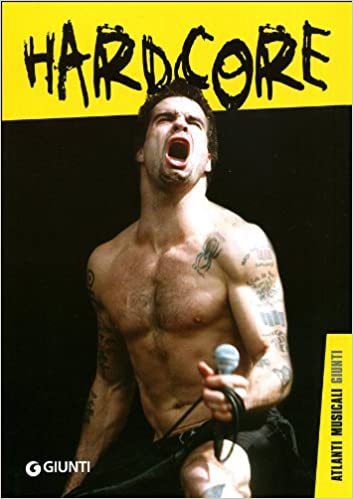


Io non lo scoprii all’uscita, a dire il vero me lo passò un mio amico anni dopo (primi 2000, ero in fissa totale con i Verdena), e rimasi stupefatto. Mi ricordo esattamente che pensai “questa è una pietra miliare, e per tutto quel tempo me l’ero perso”. Quindi mi trovo in totale sintonia con le tue sensazioni da primo ascolto.
Afterhours di sicuro uno dei migliori gruppi italiani di tutti i tempi.
Catartica è un grande disco, ma per me non c’è paragone.
Un album che secondo me doveva figurare tra i primi 10 (e mi sorprendo che non sia andata così) è Sanacore.
Ricordo che quando uscì si piazzò molto bene, in diverse classifiche dell’anno, mettendosi alle spalle nomi stranieri ben più blasonati.
Su Extra “Sanacore” è fra i primi venti dei “100 album” del rock in italiano dagli albori al 2000. Questa lista non dipendeva da me.
Ricordo che lo scopri all’epoca (e ricordo molto bene la recensione che hai riproposto qui, ricordo anche i sorrisi alla Mescal leggendola), non è il mio album preferito degli Afterhours ma decisamente è il più importante.
Una curiosità: come critico (e quindi al di là dei gusti personali) trovi abbia avuto più peso questo album o 17 re dei Litfiba che ricordo fu un altro “shock” non da poco?
Immagino che alla Mescal fossero contenti, ci mancava pure che si incazzavano. 😀
“17 re” ebbe un impatto analogo, forse anche più grande considerando i tempi più difficili per il rock italiano. Oggi, però, quei Litfiba vengono considerati una cosa “del passato” (ci sono dieci anni di differenza), mentre gli Afterhours sono ancora visti come una band attuale.
Tutti contenti (come ovvio). Mah una recensione così “pazza” me la ricordo (sempre sul Mucchio) riguardo i Sonic Youth (il recensore pazzo non me lo ricordo ma è quello che si occupava del, al tempo, rock alternativo americano).
Tornando ai Litfiba era pure tua la recensione di 17 re giusto? Finiva tipo che “pure il termine “miglior disco rock italiano dell’anno” assume un senso diminutivo.”
Sì, esatto. Qualcosa del genere.
album imprescindibile, non solo per il decennio dei 90 o per il filone del rock alternativo, ma di tutta la musica italiana. Ricordo benissimo l’effetto che mi fece quel disco quando lo sentii la prima volta e gli elogi che i miei grandi amici Scisma, appena prodotti da Manuel per il loro bel “Rosemary Plexiglas”, fecero al disco degli After, in un momento in cui ancora non sapevo se il gruppo di Agnelli fosse vero o solo un bluff, solo provocazione (Germi non mi fece certo gridare al miracolo). Ho anche il dvd e pure lì c’è la tua recensione. Cavoli, che genesi però questo disco, come ho avuto modo di capire bene leggendo il tuo “Voci d’autore” nel primo capitolo, dedicato proprio al gruppo milanese. Tuttavia, io quel famoso sondaggio lo condivido solo in parte. Ho partecipato e penso che, ad esempio, un album come “Catartica”, debut dei Marlene Kuntz non abbia proprio nulla da invidiare a “Hai paura del buio?”, sia a livello di ispirazione globale e di “urgenza” creativa, sia per la reale portata e il valore attribuito a un determinato periodo, assai florido per la musica rock nostrana
Però “Catartica” è arrivato secondo. Alla luce di quanto fosse agguerrito anche il resto della “concorrenza” è comunque un brillante risultato.
Lo scoprii due anni dopo la sua uscita, dopo averli visti in concerto al Feedback del 1999, una rassegna musicale che si teneva ad Eboli (Sa) e di sicuro il termine più adatto per definirli dopo quel concerto fu proprio “alieni”.
Sì può dire che l’hai scoperto in tempo reale, allora. Sei stato fortunato. 🙂
Album quasi unico nel panorama italiano. Gira in questo momento a volume smisurato nello stereo e non posso fare a meno di continuare ad emozionarmi ancora una volta di più. In tardi troveranno mille difetti, mille dubbi, ormai troppo noti per poterli sentire propri, ma si tratta solo delle solite velleità. Pezzo dopo pezzo me ne innamoro ogni volta sempre più
Non so se tu l’abbia scoperto in tempo reale o no, ma credo che per chi all’epoca c’era sia più facile reputarlo un album, appunto, epocale. Ciò non toglie che quanti l’hanno scoperto in ritardo hanno comunque ottime possibilità di considerarlo un magnifico manufatto alieno. 🙂